IL PENSIERO FILOSOFICO DI GIOVANNI MARULLO

E' una vera ingiustizia che il nome di Giovanni Marullo, uno dei più
grandi filosofi, almeno tra quelli caccuresi, non figuri tra i testi
scolastici. Le sue massime, i suoi aforismi, le sue perle di saggezza
che sono il condensato della filosofia di questo ex carabiniere, usciere
comunale e banditore (jettabannu) hanno formato (o almeno avrebbero
dovuto formare) diverse generazioni di caccuresi e sono sempre
attualissimi.
Cominciamo dalla più famosa con la quale ci insegna a
tenere al loro posto gli impiccioni, gli sputasentenze, i
moralisti ipocriti sempre pronti a cogliere in castagna il
prossimo:
"Ognunu se sa li menzi cazzi sui", ognuno di noi conosce la
metà dei casi suoi, figuriamoci quelli degli altri e allora come si
possono giudicare gli altri se non conosciamo bene nemmeno noi stessi
era la conclusione ineccepibile del pensatore caccurese.
Marullo soffriva molto per l'insipienza dei suoi
compaesani, i più zelanti nel dimostrare la validità del vecchio motto
latino Nemo propheta in patria con il loro servilismo nei confronti dei
forestieri che capitavano a Caccuri e" si ce 'ncuncavanu"
ovverro ci piantavano le loro radici ritrovandosi in breve tempo da
"zinzule" che erano, re. Anche per questo zu Giovanni aveva
pronta la sua spiegazione:
"Allu paise 'e ra muntagna (metafora per indicare Caccuri) c'è
aria bona, acqua bona e collocatore bonu", quindi oltre alla
salubrità del luogo, anche il collocatore che ti trovava un lavoro
magari a scapito di qualche caccurese che non gli stava particolarmente
simpatico. Solo a Caccuri, constatava con ironia amara, può capitare
che " 'Nu figliu 'e marru vuttaru diventari don Antonio Tino",
ciò uno spiantato figlio di un maestro bottaio viene salutato con il
"don", un appellativo che spettava ai nobili e agli
ecclesiastici, insomma a persone altolocate solo perché marito di una
maestra di scuola che, per la sua professione si guadagnava il
corrispondente femminile di "donna". Don Antonio, quindi, non
perché persona altolocata, nobile, membro del clero, ma perché marito
di una "donna".
Zu Giovanni era un convinto epicureo, un uomo che amava il
vino e le gozzoviglie a conferma della grandezza e della validità della
sua filosofia. Credo meriterebbe l'intitolazione di una strada o, come
suggeriva più volte il mio amico Peppino Lopez, un monumento.
CACCURI,
CURAGGIU!
di Peppino Marino

Quannu
Caccuri era ‘nu paise
Chjiunu
re gente e senza case chiuse,
cum’era
bellu, cumu era accogliente,
chi
belle rughe, quanta brava gente!
Mentre
c’era ancora la Pullara(1),
ciucciari,
zappaturi, pecurari,
furgiari,
marrurasci e quararari,
già
azati, se mintianu a fatigare.
‘U
vecchiu ‘e Catanzaru aperìa lu barru(2)
e
za Luisa la putiga ‘e vinu,
zu
Rusariu carricava lu carru,
zu
Rocco carricava lu trainu.
‘Ntra
lu salone poi, zu Gennarinu,
ch’era
‘nu tipu chi ‘un vattia la fiacca,
mintìa
‘nu suprataccu a ‘nu tappinu
mentre
Giuvanni Gallu cusìa ‘na giacca.
Poi
c’erari ‘a Marrucarmina, za Mariuzza,
affaccennata
a misurare ‘a pezza
‘e
taffettà, pe’ lu corredu ‘e Annuzza,
chilla
e ru vasciu ‘ntra la vinelluzza.
Cchiù
avanti ancora, ‘a forgia ‘e zu Michele
E
zu Michele chi ferrava ‘nu sceccu
E
ancora, ‘u putighinu ‘e Maria Mele
Chjiunu
re spuntaturu e de tabbaccu.
E
la putiga ‘e za Rosina Faziu,
‘a
chjianca ‘e Luiginu Iacumetta,
e
chilli tempi se pagava lu daziu
puru
si macellava ‘na crapetta.
‘Nguacciu
la chjianca c’era l’osteria
‘e
Caterina Pisanu e, si ce jia,
manciava
‘a tielluzza, ‘u spezzatinu…
e
te sculava puru ‘u litru ‘e vinu.
E
alla Misericordia quanta gente!
Cu’
l’ufficiale, don Nicola Brancati,
alla
posta, ‘ntru vasciu ‘e ri Lucente
C’era
sempre ‘na fulla ‘e penzionati
Chissu
era ‘n ufficiale ‘e ru Casinu
Ch’aviari
‘nu vecchjiu Topolinu
E
chi a Caccuri, pe’ cchiù de vint’anni,
stava
de casa due marru Giuvanni.(3)
E
quanta gente ‘ntra lu Vinculatu,
allu
Trabbuccu e puru alla Iureca,
allu
Pizzettu ci n’era ‘na freca,
lu
Mururuttu lu cchiù popolatu.
‘Ntra
varberia ‘e Luiginu ‘u Pittaru,
‘Nntr
‘u barru re Micuzzu lu Biunnu,
alla
putiga ‘e Franciscu l’ogliularu
o
a chilla ‘e Sarbature Capitunnu.
E
mo, addue è juta tutta chilla gente?
‘Ntra
‘stu paise ‘un c’è rimastu nente,
è
morta ‘a gente, è mortu lu paise
e
nue, ogni jornu, ne pagamu ‘e spise.
Giramu
scunsulati pe’ le vie,
senza
scontare mancu ‘nu cristianu,
‘u
core s’inchia’ de malinconie
e
nue ne morimu chianu, chianu.
Però
accussì ‘un se pò jire avanti
L’hamu
‘e finire cu tutti ‘sti chianti!
Ca
si, pe’ casu, se ‘nzigna a lottare,
Caccuri
se po’ ancora ‘mpopolare.
Ca
c’è sta’ gente laboriosa e sperta
Ca
si volissa po’ canciare ‘a sorte
Damuce
forze e mezzi e, certamente,
riofiorisciari
Caccuri e la sua gente.
1) La stella polare
2) Oggi bar Mercuri
3) La casa di Giovanni Pasculli in viale Convento, oggi casa Basile
GENERAZIONE ANNI
40
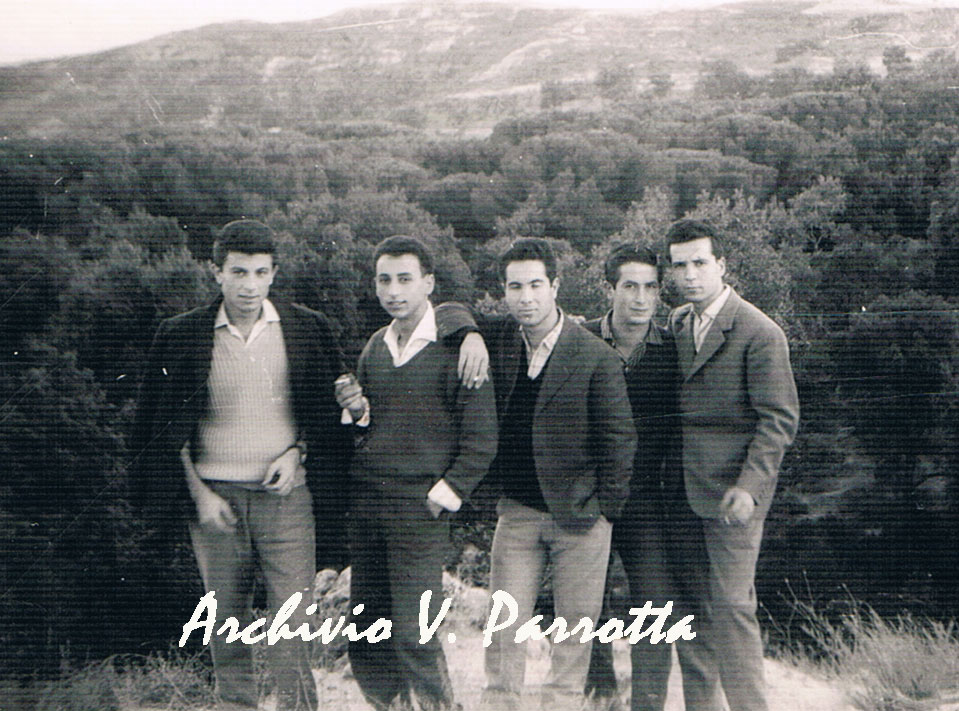
Davvero bella questa foto che mi ha fatto
pervenire mio cugino Vincenzo Parrotta e che ritrae un gruppo di ragazzi
caccuresi degli anni 40. Da sinistra a destra si riconoscono Graziano
Tallerico, Vincenzo Parrotta, Francesco Gigliotti, Totò Pitaro e Renato
Gigliotti. Fu scattata verso la fine degli anni 50 a Munnello e ci
mostra una splendida, ancora incontaminata Serra del Cucco, una delle
tre colline che circondano l'abitato. Per fortuna esistono queste
vecchie foto che ci restituiscono i luoghi dell'infanzia così come li
abbiamo conosciuti.
RICICLA E RISPARMI SEMPRE

Di questi tempi nei quali aumenta
tutto spaventosamente giorno per giorno, nonostante i tagli alle accise
di Salvini e la social card da 380 euro della Meloni, ognuno cerca di
ingegnarsi come può per procurarsi ciò di cui ha bisogno spendendo
poco, possibilmente a costo zero. Così anch'io cerco di evitare spese
voluttuarie di procurarmi con poca spesa ciò che mi serve.
Tre anni fa ho messo a dimora alcune piante di
agrumi, ma la crescita era stentata, le foglie si arricciavano e non si
vedeva nemmeno un frutto. Ho chiesto lumi a qualche esperto e mi è
stato spiegato che gli agrumi hanno bisogno di essere concimati con un
concime ferroso. Ho provato e la cosa funzionava, ma mentre le piante
prendevano vigore, il mio portafoglio cominciava a languire. Poi un
giorno ho letto da qualche parte che uno se lo poteva fare anche da
solo, così ho voluto provare. Ho sistemato in una vecchia pentola un
bel po' di chiodi di ferro riciclati che non mi servivano e l'ho
riempita di acqua per molti giorni. Poi l'ho filtrata e raccolto in una
tanica un bel po' di concime ferroso che non sarà potente come quello
prodotto dall'industria, ma è a costo zero e pure ecologico. Da qualche
settimana, visto che anche questo autarchico pare discretamente
efficace, ho raddoppiato la produzione.
QUANNU TE GAPANU L'ANNI

Oggi mi è tornata
alla mente una storiella che mi raccontava spesso nonno Saverio, un
aforisma sull'imprevidenza, sul vivere alla giornata senza preoccuparsi
del futuro, insomma una sconfessione del famoso "carpe diem."
La storia è questa:
C'era una volta un bravo artigiano, di nome mastro Giovanni, uno
di quelli che conosce molto bene il proprio mestiere e che lavora
onestamente e con grande perizia e per questo ha sempre una buona e
numerosa clientela. Grazie al suo lavoro era riuscito ad accumulare una
discreta fortuna e, non avendo famiglia, non aveva nemmeno eredi.
Arrivato a 70 anni dopo aver lavorato sempre duramente senza mai
concedersi uno svago, pensò che era giunto il momento di cambiare vita
e di godersi il frutto del suo lavoro in bagordi, donne e trastulli
vari, tanto, pensava che gli restavano ormai pochi anni di vita e non
sarebbe certamente finito in miseria. Perciò cominciò a dilapidare il
patrimonio e a scialacquare senza preoccuparsi del futuro. Arrivarono
così gli 80 anni, poi
gli 85, ma la morte non si faceva vedere. A 87 anni gli era
rimasto ormai ben poco, ma la sua fede incrollabile in un imminente
trapasso non scemava e così si sparò le ultime cartucce.
A 90 anni si ritrovò nella miseria più nera e rischiava ormai
si di morire, ma d'inedia, così finì sul ciglio di una strada a
implorare la carità dei passanti: "Faciti 'a limosina a marru
Giuvanni ca l'hau gapatu l'anni."
IL MIO PAESE
di
Elisabetta
De Marco

L'amica Elisa De Marco mi ha
fatto pervenire questa poesia nella quale con semplicità, con amore,
oserei dire con dolcezza e pudore descrive la Caccuri della sua infanzia
e della sua giovinezza, di quando ancora la vita non era del tutto
fuggita dall'antico borgo e molti usci non erano ancora sbarrati, una
Caccuri che non si poteva non amare come l'amava e la ama ancora
l'Autrice e come l'amano tutti quelli che ne sono lontani.
Complimenti, cara Elisa, e grazie per avermi fatto partecipe di
questo tuo piccolo, prezioso gioiellino.
Il castello fiabesco
incastonato tra il cielo e
le rocce scoscese
TRONEGGIA
Sul borgo dall'alto.
Le viuzze solitarie
Riecheggiano voci e rumori
di un tempo lontano
ancora vivo nei meandri della memoria.
Le case di pietra fissano immobili i
passanti curiosi in cerca
di arte e bellezza.
Il profumo dei gelsi
Inebria di gioia l'aria
fresca e leggera.
La grande croce
silenziosa
incontra lo sguardo
dei moderni viandanti
che frettolosamente
percorron la curva che
risale la strada.
Le rondini in cerchio
garriscono felici
sorvolando la" villa " fiorita ..
Le urla di bimbi festosi
riempiono di allegra
armonia
Il paesello malinconico che
Avvolto in una coltre di nuvole
aspetta paziente la festa
del Santo ancora lontana.
LA CALABRIA CHE FA
SPERARE

Continuando " il mio
viaggio" alla scoperta delle produzioni tipiche e non della nostra
regione, quasi sempre comunque eccellenze, questa volta sono capitato a
Celico dove non ci sono solo monaci "di spirito imprenditoriale
dotati", ma, evidentemente, altri imprenditori ben più bravi e
dinamici che producono, tra le altre cose, questo eccellente formaggio
ovicaprino al vino commercializzato in un discount della zona. Avevo
sentito parlare di questo singolare modo di stagionare il formaggio
immergendolo per qualche tempo nelle vinacce, ma pensavo fosse praticato
solo in Trentino o nel Tirolo, invece scopro che lo si fa anche in
Calabria. D'altra parte nella zona di Celico, di Spezzano e di
altre frazioni di Casali del Manco, ma anche in molte altre contrade
della Regione sono nate numerose e moderne aziende di
trasformazione e conservazione dei nostri prodotti agro pastorali che
forse assicureranno futuro migliore alla nostra terra, un futuro che
dovrà necessariamente puntare su queste cose oltre che sul turismo che
da solo non risolve alcun problema. Bisognerebbe invece produrre
eccellenze anche e soprattutto per venderle ai turisti; solo con una
simile sinergia il turismo diventa un vero affare. La Calabria che fa
bene sperare esiste davvero.
LIETTO
SiCURO E PANE BEN DIVISO

A coloro i quali, politici, opinionisti, "giornalisti",
tuttologi, ma anche tanta gente comune, a quelli a volte più disperati
dei disperati che arrivano sulle carrette del mare, ma che, invece di
solidarizzare con i loro simili ripetono scioccamente le argomentazioni
dei riccastri e dei legaioli descrivendo gli immigrati come i
responsabili di tutti i mali si potrebbe rispondere con le stupende
parole che Eduardo De Filippo mette in bocca a Dio nella bellissima
commedia De Pretore Vincenzo: "Capisco il malumore, a vuje ve fa
paura De Pretore ch’è mariunciello, e ca ve po’ arrubbà? State
tranquilli, ne rispondo io. Chisto perciò se chiamma Paraviso: lietto
sicuro, pane ben diviso…Neh, De Pretore c’arrubbasse a ffà?"
Davvero pensate che questa povera umanità venga da noi perché
"Perché a nui 'nci piace viaggiare canoscere altre genti, altri
paesi:l'America, l'Australia, la Francia, la Germania, la Svizzera, il
Belgio..." come canta il nostro Otello Profazio? Davvero pesate che
lascino "un paradiso" per venire a rompere le scatole ai
leghisti? "Paradiso è letto sicuro e tetto ben diviso"; se
nel mondo ci fosse davvero dappertutto i migranti che "migrassero a
ffà?"
ACCADDE
OGGI: 3 MARZO 1803: NASCE IL VESCO DE FRANCO
.jpg)
Esattamente 220 anni fa, il 3 marzo
del 1803 nasceva a Caccuri nel palazzo di via Buonasera da Antonio e
dalla nobildonna Agata Florio, monsignor Raffaele De Franco, arcivescovo
di Catanzaro. Compì gli studi nel seminario di Catanzaro
dove ricevette la “confirmazione, la tonsura ed i quattro
ordini minori” da monsignor Giovanni Francesco D’Alessandria. Si
trasferì, quindi, a Roma dove fu ordinato suddiacono dal cardinale
Della Porta Rodiani e diacono dal cardinale Zurlo.
Nel 1825 divenne sacerdote. Nel 1819 era stato designato
quale canonico della collegiata di Caccuri e nel 1827 divenne vicario
generale di mons. Giosuè Saggese, arcivescovo di Chieti. Il
21 gennaio del 1852 fu nominato vescovo di Catanzaro, diocesi che governò
per ben 31 anni lasciandovi la sua impronta indelebile. Nel
1869 partecipò al Concilio Ecumenico a Roma e fu nominato componente
della Commissione dei Canonisti nella quale ebbe modo di farsi
apprezzare per la vasta e profonda conoscenza del diritto canonico.
Durante il suo mandato pastorale nella diocesi di Catanzaro fece
ricostruire interamente il Palazzo vescovile e fece ingrandire il
Seminario che egli stesso aveva frequentato in gioventù. Fondò anche
l’Istituto dei sordomuti e fece frequentare, a sue spese, a Napoli, un
corso di istruzione per l’insegnamento a questa categoria di portatori
di handicap, al sacerdote Luigi Spadola. Nell’ottobre del 1880 tenne
un sinodo diocesano, dopo circa un secolo dall’ultimo che era stato
proclamato dal 1vescovo Gori. Fece inoltre erigere il campanile del
Duomo di Catanzaro, sotto la direzione dell’architetto Michele
Manfredi facendovi collocare cinque campane. Mons. De Franco, oltre che
curare le anime, si interessava anche, più o meno
discretamente, di politica, ingerendosi pesantemente nelle vicende
risorgimentali. Questo è, almeno, ciò che sospettava il Segretario Generale
dell’Intendenza Stefano Berni che, il 19 ottobre del 1861, lo
diffidava dal prendere posizione contro il plebiscito per
l’annessione, così come correva voce nel circondario. Ma l’abile
plelato seppe sempre sviare abilmente i sospetti continuando a svolgere
tranquillamente la sua missione pastorale fino al giorno della morte che
lo colse il 23 agosto del 1883. Fu sepolto nel cimitero di Catanzaro.
Successivamente un’urna contenente documenti e reliquie del vescovo
caccurese fu collocata nella cappella De Franco della chiesa di S. Maria
delle Grazie in Caccuri ove rimase fino alla fine degli anni ’60.
LAMENTO
FUNEBRE PER LA MORTE DI FRANCESCO CARNEVALE. FILOSOFO EDONISTA
Testo e musica di Peppino Marino
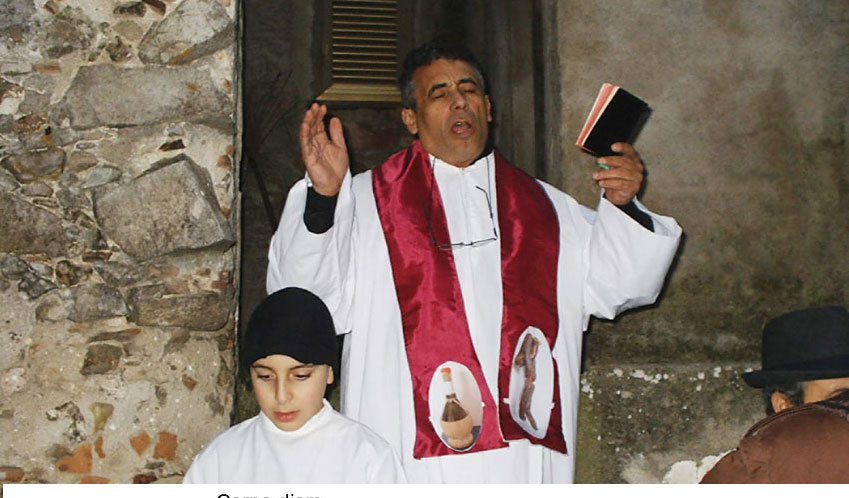
In occasione del
Carnevale invito tutti voi a recitare le orazioni funebri per
l'animaccia del nostro carissimo amico Francesco Carnevale che ci lascia
in questo allegro giorno.
Ohi
Franciscu, ohi Franciscu
Te
piaciari ‘u casu friscu,
‘U
prisuttu, ‘a suppressata
‘A
sciungata ‘un l’ha mai lassata,
‘A
stigliula, ‘a tielluzza,
‘A
ricotta ‘ntra l’erbuzza. (1)
Sulu
‘a fatiga ‘un te piacia!
Me
ricia: “’Un fa ppe mia!”
Tu
li costi nun ti l’ha mai rutti,
Ma
lu vinu ‘u spartia cu tutti. (1)
Mo
chi si’ mortu, però si’ cuntentu
Ca
‘un t' hau mai pijiatu l’acqua e lu ventu,
E
all’atru munnu, signu sicura,
ca
pecurii a ogne ura.
Gora, Franciscu, ca ‘ntra lu munnu
‘Un
mora quatratu chine nescia tunnu.
O
Patreternu, ajuta l’ajutatu
Ca
lu pezzente c’è sempre mparatu.
(1) Ripetere
due volte
Dies
Carpe
Orazione
funebre per Carnevale in latino maccheronico
di
Peppino Marino
Sull'aria del Dies Irae di Tommaso da Celano
Carpe
diem! Carpe diem!
Trotae
et ancillae semel in die
Et
sazizze
Et
sazizze et suppressatae
Manducate
Manducate
at tonnellate
Quia
nunc est bibendum,
Nihil
labor qui est orrendum !
Et
si vis
Et
si vis campare cent’anni,
Magna
et bevi
Magna
et bevi cum tuis cumpagni.
Deus
Bacchus, deus Bacchus,
Vinus,
fimminae et tabaccus,
Si
riducunt
Si
riducunt hominem in cenere
Tamen
vitam
Tamen
vitam te fannu godere!
Nunc
mea gola est siccata.
Accurrite
Accurrite
cum cannata.
ROSARIO
Peppino Marino
Sacerdote
Patreternu, Patreternu
De
le pene de lu ‘mpernu
Liberamme,
ppe’ piacire
‘Un
me fare mai morire !
Alla
morte, 'a via cecata,
Minaccella
‘na palata!
Popolo E
Carnelevaru è mortu e li maccarruni su’ cotti
E lu casu
s’ha de grattare
Bono
venutu, Carnelevaru.
Sacerdote Pregu
a Santa Liberata
Ch’
‘un me manchi la cannata.
O Madonna tantu bella,
ch’ ‘un me manchi la tiella!
Popolo Emmera,
emmera, emmera,
tutti
i jorni ìe ‘na manera
e
n’avimu re mpriacare alla faccia ‘e Carnalevaru.
Sacerdote Santu
Roccu e Santu Janni
Risparmiatime
l’affanni.
O
gloriosa Santa Rita
Famme fare ‘a bella vita!
Popolo Emmera,
emmera, emmera,
tutti
i jorni ìe ‘na manera
e
n’avimu re mpriacare alla faccia ‘e Carnalevaru.
Sacerdote San
Luinu e San Pasquale,
carne
‘e bifaru e maiale.
San
Pasquale e San Luinu
Ch’ ‘un me manchi mai lu vinu
E
ppe’ l’atri l’acqua appenninu.
L'ISOLA
IMBIANCATA

Quando, come dicevano
i nostri vecchi, "Tremanu i 'mpanti" (tremano, battono i denti
i fanti", teni i peri friddi ch' 'un se 'mpocanu mancu s' 'e minti
'ntre frasje e te gratti l'ugne, ovvero quando il freddo fa sul serio,
la neve cade anche sulle isole, come la mia "Isola Amena",
stamattina ammantata da una coltre bianca che in alcuni angolI superava
i 30 centimetri. A parte la bellezza del suo candido mantello che
copre la terra, gioca con in rami degli alberi e con i cespugli creando
effetti stupefacenti che deliziano gli occhi e il cuore, la neve
è la benvenuta per le colture e per le sorgenti. Adesso abbiamo la
certezza che la prossima estate l'acqua non ci mancherà.
CAMINA CA TE 'MPOCANU I
PERI
di Peppino Marino

Caccuri è sempre stata una cittadina di grandi filosofi di quelli che,
come osservava il compianto onorevole Aldo Moro, non conoscevano la
filosofia, “ma la sapevano” la producevano, la divulgavano; da
Ciccillo Belcastro a Giovanni Marullo, a Giovanni Gallo (Rizzeri), ad
Antonio Manfreda. Un altro grande filosofo caccurese fu un certo
Gigliotti più noto col soprannome di Tribbiziu ereditato probabilmente
da qualche antenato che praticava tre vizi. Il Gigliotti nel corso delle
sue meditazioni sull'agire umano aveva notato che quando una persona ha
i piedi infreddoliti dal gelo, dal freddo intenso dei mesi invernali,
non trova riposo, si agita, diventa irascibile, nervosa, intrattabile,
litigiosa. Per tornare normale, trattabile, amabile, ragionevole c’è
un solo rimedio: scaldare i piedi ricavandone una sensazione di
benessere. Se si ha davanti un bel fuoco non ci sono problemi, basta
togliersi le scarpe ed esporli alla fiamma facendo attenzione per
evitare di fare come Pinocchio, ma se si è fuori, in un luogo freddo
c’è un solo rimedio, come consigliava Tribbiziu: camminare. Infatti
questa intelligentissima persona coniò una massima, una esortazione che
ebbe grande fortuna e che era conosciuta da tutti i caccuresi: “Camina
ca te ‘mpocanu i peri”, cammina ché ti scaldi i piedi, diventata
col tempo un’amabile esortazione ad andare in un famoso paese
consigliato, come osservava con grande acume il grande Gigi Proietti,
dalle agenzie di viaggi.
FEBBRAIO
di Peppino Marino

Salutiamo il mese di
febbraio con questa filastrocca scritta guardando al passato quando
ancora febbraio era un mese freddo e si vedeva anche la neve e quando
ancora c'era il Carnevale e si aspettava febbraio per mettere da parte
le angosce e divertirsi spensieratamente per tre giorni come ai tempi
dei Saturnali. Oggi. invece, la neve è sparita assieme al gelo e non
c'è più il gusto dell'attesa del Carnevale che in Italia, dura tutto
l'anno. Per eventuali dubbi accendere il televisore in una qualsiasi
delle 24 ore della giornata.
P.S
Le maschere nella foto sono tutte e tre meridionali, la siciliana Peppe
Nappa a sinistra, la calabrese Capitan Giangurgolo al centro e la
napoletana Pulcinella ingiustamente considerata "uomo da
niente". A parte Pulcinella, è difficile sentire qualcuno che,
parlando di maschere, faccia cenno, a parte la notissima Pulcinella, ad
altre maschere meridionali come se il sud non esistesse.
Filastrocca
dell’arcolaio
per
il mese di febbraio,
di
tutti gli altri il più piccino,
ma,
anche il più freddo e malandrino
ché
fa soffrire la povera gente
che
non ha legna, che non ha niente.
Questo
mese breve, breve
copre
il monte e il piano di neve,
gela
i fiumi e le fontane
e
fa soffrire chi è senza pane.
Per
fortuna c’è il Carnevale
Sempre
allegro, giocoso e ilare
Con
frizzi, lazzi e mascherine
per
far felici bimbi e bambine.
Anche
i grandi allora son contenti
e
metton da parte affanni e tormenti.
Febbraio
corto e maledetto,
avrai,
forse, qualche difetto,
ma
per tre giorni scacci i guai
per renderci allegri, felici e gai.
Tre
luminari a consulto
di Peppino Marino

Oggi
vi regalo questa novella scritta qualche anno fa. I fatti narrati, sono
frutto di fantasia, anche se una sessantina di anni fa per le strade del nostro paese non era
difficile imbattersi in scene come questa.
L'asino di zu Nicola era
ammalato da diversi giorni: una bruttissima piaga era comparsa sulla
schiena del povero animale lì, a pochi centimetri dalla striscia
prodotta dallo strofinio della cinghia del basto dove il pelame stentava
a crescere. Era chiaro che la piaga non era stata prodotta dai
finimenti, né l'asinello si era ferito. Evidentemente si trattava di
una malattia
sconosciuta, perlomeno a zu Nicola.
Il pover'uomo era disperato:
il malanno di Frisichello lo preoccupava seriamente, non tanto per
l'aiuto che la povera bestia poteva ancora dargli, tanto, oramai,
neanche lui se la sentiva più di andare a lavorare, quanto perché,
dopo la morte di za Concetta era rimasto solo con l'animale col quale
divideva il grazioso appartamentino scavato a colpi di piccone
nell'arenaria della collinetta. Chiese perciò aiuto agli amici e questi
lo indirizzarono a tre celebri luminari del paese, da anni impegnati
nella nobile arte della medicina asinina.
L'esperienza consolidata di
zu Giuseppe, zu Ntone e zu Domenico, acquisita con l'esercizio onorato
della professione, rappresentava una vera garanzia e zu Nicola si recò
fiducioso all'appuntamento conducendo per la cavezza il mite Frisichello.
L'ambulatorio dei tre specialisti si trovava all'aperto, in un angolo
della piazza del paese ai piedi della gradinata della chiesa di S.
Francesco.
Iniziò
subito la visita. Zu Nicola stringeva la cavezza dell'asino volgendo le
spalle alla gradinata, mentre i dottori esaminavano il paziente. Cominciò zu Domenico che strizzò
tre o quattro volte la piaga. Frisichello, evidentemente, provò una
fitta alla schiena perché diede uno strattone rinculando e mandando
a terra bocconi zu Nicola. Seguì puntuale l'immancabile
bestemmia del vecchio che si rialzò stringendo a due mani la cavezza e
puntando i piedi. "Garrese, sentenziò zu Domenico , brutto
affare!". "Macchè, esclamò zu Nicola che aveva ripreso a
torturare Frisichello, é una pitinia" e strizzò più forte.
Frisichello si impennò e
strattonò. Uhhh, botta ‘e sangu! gridò zu Nicola cercando di calmare
l'animale, mentre il terzo primario si avvicinava al somaro. Nuova
strizzata e nuova diagnosi, mentre il povero animale manifestava a suo
modo il dissenso per quelle diagnosi così superficiali. A questo punto
si accese una disputa animata tra i tre ricercatori che tentavano di
dimostrare, a colpi di strizzate, l'esattezza della propria diagnosi,
mentre il povero Frisichello scalciava e strattonava ripetutamente e zu
Nicola tirava a più non posso la cavezza per tenere fermo il
malcapitato somaro.
All'improvviso successe
l'irreparabile: la fune, evidentemente logorata, si spezzò ed il povero
zu Nicola ruzzolò per terra andando a saggiare col cranio pelato la
consistenza di uno dei gradini, mentre Frisichello se la dava a gambe
incredulo per quella insperata fortuna che lo sottraeva al supplizio
della scienza medica. Il sangue sgorgò copioso dal capo di zu Nicola e
gli specialisti accorsero verso il vecchio per un nuovo, più
interessante consulto. Zu Nicola, terrorizzato, lesse negli occhi le
intenzioni di quegli aspiranti al Nobel e, con uno scatto impensabile
per l'età si alzò e se la diede a gambe inseguito dal suo amato
Frisichello barricandosi con lui nell'accogliente dimora.
SOGNANDO UNA BELLA
MANGIATA

Il pranzo
è servito
di Peppino Marino
Filastrocca
della vecchia mucca
La
Pasqualina ha cotto la zucca
Mentre
cuoceva l’arrosto è bruciato
Perciò
ripiega sullo stufato
E
lo stufato ha cotto a puntino,
poi
va in cantina a spillare il vino
un
vino dolce, un vino moscato,
un
buon formaggio stagionato,
la
frutta, il dolce, il caffè, il gelato,
ed
ecco il pranzo è già terminato,
di
digerire cerchiamo in fretta
che
già la cena oramai ci aspetta.
PATATINE? NON SERVE COMPRARLE

Ci sono patatine e patatine; ci sono quelle che si comprano nei negozi
nella busta o che si mangiano nei fast food con olio di colza, olio di
semi di soia, aroma di carne, grano idolizzato, acido citrico,
dimetilsilossano, terz-buti-idrochinone, destrosio e chissà cos'altro
ancora e ci sono quelle che ti prepari in casa, magari biologiche
coltivate da te stesso, tagliate a fette sottilissime come le ostie col
robot di cucina e te le friggi da solo sul fornello a gas e spolverate
leggermente di sale dopo fritte. Prepararsi in casa delle croccanti,
saporite patatine non è difficile, non è costoso ma, soprattutto, è
salutare, soprattutto se in casa ci sono bambini o fanciulli e come
sapore non hanno niente da invidiare a quelle comprate.
L'EPIFANIA, LA NOTTE DEI PRODIGI

Buona sera, amici, stanotte è la
notte dell'Epifania, quella nella quale la Befana, la simpatica vecchina
amica dei bambini si cala attraverso i nostri camini per portare i
regali ai pargoli, ma è anche la notte di straordinari prodigi. A
mezzanotte in punto, infatti, dalle fontane sgorgherà olio extravergine
di oliva e le pietre sulle strade si trasformeranno in grandi pepite.
Ah, vi siete ricordati di dare abbondante cibo ai vostri animali
domestici? Per il vostro bene mi auguro di si perché a mezzanotte
parleranno col Creatore e li avete lasciati digiuni il Padreterno vi
maledirà. Così ci insegnavano i nostri nonni caccuresi. Buona Epifania
a tutti voi.
TURDILLI E VINO

Ed ecco a voi i turdilli calabresi
(in questo caso caccuresi) preparati con la tradizionale ricetta
delle nostre nonne da non confondere con i pizzulioni (struffoli). I
turdilli in casa Marino si rigano rigorosamente cu' lu crivu 'e ru granu
e si ricoprono di miele. Noi li preferiamo cos', senza aggiunta di
canditi o confettini, anche perché si sposerebbero male col vino come
ci insegnavano i nostri nonni del XIX che i turdilli e i pizzulioni li
accompagnavano cin un buon bicchiere di vino rosso. Personalmente ho
scoperto che col sidro di mele sono veramente 'na cosa fina-
'U CUMPETTU

La Calabria e la
Sicilia, da sempre terra di conquista di decine di popoli stranieri, dai
normanni agli arabi, dagli svevi agli angioni, dai bizantini agli
aragonesi sono due regioni tutto sommato fortunate perché le varie
"contaminazioni culturali" hanno prodotto un notevolissimo
arricchimento anche gastronomico. Ogni popolo che si è succeduto nel
dominio di queste due regioni della penisola, tranne i piemontesi,
ha portato qualcosa, ci ha insegnato qualcosa ha contribuito ad
arricchirci culturalmente e, a volte anche economicamente. E'
incredibile la quantità di piatti, di conserve, di dolci calabresi di
origine greca, araba e di altri popoli: dalla lestopitta alla pitta 'mpigliata,
le fave dei morti, i jaluni, le cuzzupe, le 'ngute, i muccellati,
i mostacciuoli, 'a scirubetta e, tra questi, 'u cumpettu o cupta, un
torrone a base di mosto cotto o miele, semi di sesamo (giurgiulena in
caccurese o giggiolena in altri paesi), mandorle e bucce d'arancia. A
Badolato, il paese di mia moglie, lo preparano col mosto cotto che
richiede molto più tempo, ma è ottimo anche col miele. Personalmente
lo preferisco col miele.
UNA GRANDE COMUNITà

Tra le tante tessere che
porto nel portafogli questa è una delle più care, una tessera che
risveglia in me l'orgoglio di appartenere a una comunità di centinaia
di miglia, forse di milioni di italiani che si battono per un nobile
ideale, contro la sofferenza, contro la morte, per il progresso
scientifico, per salvare milioni di uomini, donne e bambini in tutto il
mondo, un po' come la tessera del glorioso PCI che ho ritirato per 20
anni con gioia, trepidazione e orgoglio prima che una manica di
sciagurati decise di scioglierlo e che oggi conservo tra le mie
reliquie.
Purtroppo (e per fortuna) in questo maledetto paese la
ricerca scientifica viene finanziata quasi esclusivamente dai cittadini,
mentre lo Stato fa l'esatto contrario e continua a foraggiare i
fabbricanti e i mercanti di armi, strumenti di morte, e l'invio
delle stesse ai paesi in guerra senza mai rendersi protagonista di una
pur qualsiasi insignificante iniziativa diplomatica. D'altra parte,
anche chi segue quotidianamente la politica in questi ultimi decenni fa
fatica a ricordare uno dei tanti ministri degli esteri che hanno
scaldato la poltrona della Farnesina, a parte Di Maio per le sue
clamorose gaffe, dal momento che dalla fine di quella che i giornalisti
si ostinano a chiamare Prima Repubblica abbiamo delegato la nostra
politica estera agli USA. Ma tornando alla ricerca, nonostante i
generosi sforzi di milioni di cittadini, i fondi sono sempre esigui, in
Italia si fa poca ricerca, migliaia di giovani ricercatori, cervelli
finissimi, sono costretti ogni anno a emigrare in paesi dove la ricerca
si fa sul serio, una ricerca generosamente finanziata, libera da pastoie
come quelle di quel genio di ministro che voleva sapere prima di
finanziarla a quali risultati sarebbe approdata. Così anno dopo anno,
mese dopo mese, migliaia di giovani formati in Italia spendendo un
patrimonio per farli studiare, vanno ad arricchire paesi stranieri.
Purtroppo non è una novità in un paese nato dalla Resistenza e finito
subito dopo nelle mani di un
politico che invitava i giovani a imparare le lingue e andare all'estero
ovvero il contrario dell'invito gramsciano "Istruitevi, perché
avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché
avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché
avremo bisogno di tutta la nostra forza"
SAN NICOLA, OGNE VALLUNE SONA

Oggi 6 dicembre la chiesa festeggia San
Nicola da Myra, patrono di Bari e di Merano dove però viene chiamato
San Nicolò E che in Olanda e nei paesi nordici diventa Santa Claus e
viene scambiato per Babbo Natale. A Merano il duomo della città è
intitolato appunto al patrono. Fu in questo tempio che a Natale del 1961
ascoltai per la prima volta la versione originale di Stille Nacht che io
conoscevo come Astro del ciel cantata da un coro tirolese. Nella mia
ingenua, bambinesca ignoranza mi sembrava strano che i tirolesi
cantassero questa bellissima canzone italiana, ma appresi presto dalla
mia professoressa di tedesco della scuola media che si trattava di un
canto austriaco che ci fece imparare a memoria.
Da bambino, invece, appresi da nonno Saverio che "A
San Nicola, ogne vallune sona e ogni mantra fa la prova. Effettivamente
dopo il temporale di tre giorni fa i "valluni sonanu" per
davvero, quanto alle "mantre" non credo facciano "la
prova", anche perché nella nostra zona ne sono rimaste davvero
pochissime.
IL
CAPOLAVORO ASSOLUTO DI PEPPINO NESCI

Credo sia molto difficile, almeno per me, stilare una graduatoria delle
opere dell'amico Peppino Nesci che ci lasciò in una triste giornata del
mese di giugno del 2006, ma con questa XIII stazione della via Crucis
credo abbia raggiunto le vette del sublime. Quel cielo infuocato tipico
dei suoi paesaggi che si richiamano alle opere di Carlo Quaglia e alla
scuola di Scipione, coperto di nubi nere che avvolgono minacciose il
Calvario a sottolineare la drammaticità dell'evento mentre il Messia
esala l'ultimo respiro, i volti addolorati e rassegnati di Maria e della
Maddalena nei quali si legge un dolore muto e lacerante, la posizione e
le piaghe del corpo del Cristo che testimoniano la sofferenza atroce e
sovrumana del figlio di Dio per
l'espiazione dei tutti i peccati dell'umanità sono la massima
espressione artistica di un pittore che maneggiava il pennello come lo
scalpello o la bocciarda dello scultore del marmo, capace di dar vita,
in pochi minuti, a un capolavoro. Si, questa Via Crucis e la serie di
quadri sulla caduta e la distruzione di Troia, due tra i più
tragici eventi dell'antichità, per la bellezza cromatica, per la
capacità di dipingere il dramma e il dolore, lo strazio dei corpi e
delle anime con poche pennellate, credo rappresentino il meglio della
produzione del nostro amico e compaesano, prolifico e indimenticabile
pittore. Peccato che questo capolavoro, assieme alle altre 13 tavole,
sia stato rifiutato dal suo paese e donato alla chiesa dell'Olivaro di
San Giovanni in Fiore il cui parroco accettò il dono con gioia e
gratitudine.
DOMENICO
SISCA, IL MONSIGNORE STORICO E PEDAGOGO
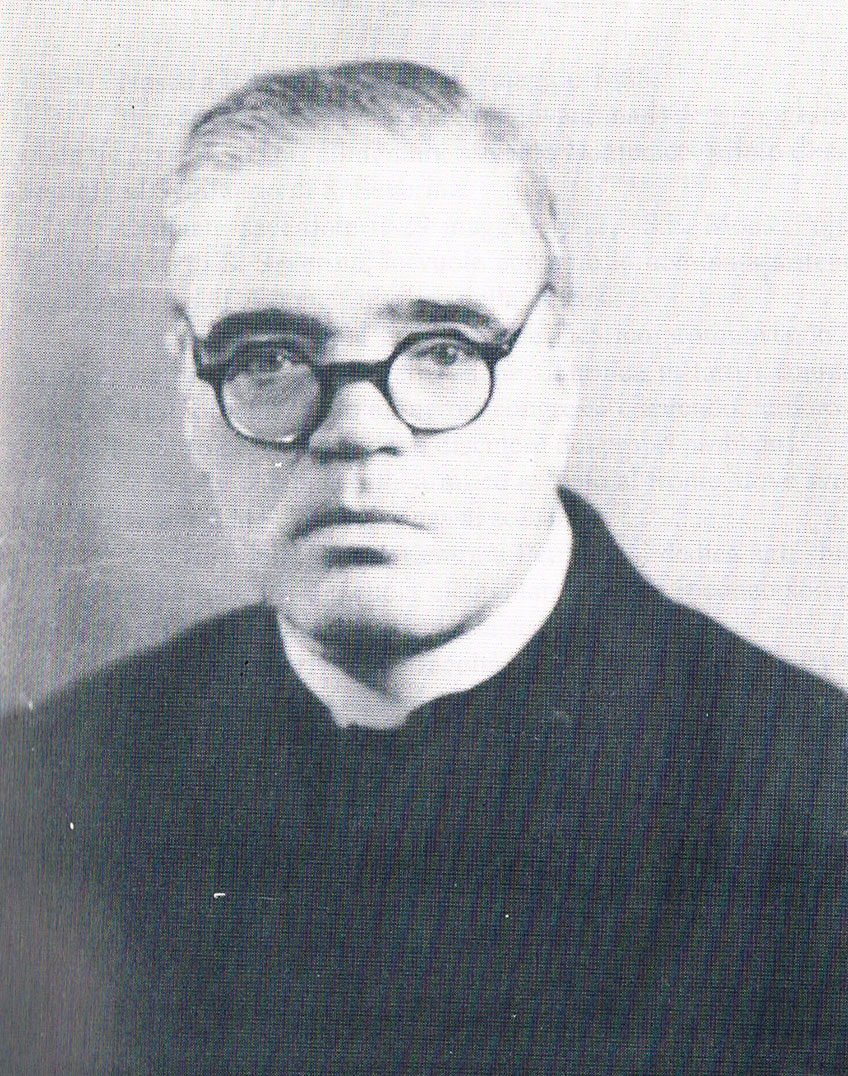
Oggi voglio parlarvi di un
importante personaggio petilino di origini caccuresi che ebbe un ruolo
di primo piano nella chiesa e nella scuola del Crotonese, oltre che
nella storiografia locale. Si tratta di mons. Domenico Sisca, sacerdote,
insegnante, poi direttore didattico e ispettore scolastico di
Crotone.
Domenico Sisca nacque a Petilia Policastro il 5 maggio 1888
da Francesco e da Giovannina Belcastro proprietari di un negozio di
alimentari. Giovannina era figlia di Ferdinando Belcastro, caccurese,
fratello di Francesco (il mio bisnonno Ciccillo) usciere comunale di
Caccuri, quindi parente anche del professore Francesco Cosco e
dell'avvocato e drammaturgo Nino Cosco.
Avviato al Seminario di Santa,
conseguì il diploma di abilitazione magistrale e il 29 maggio del 1912
venne ordinato sacerdote. Diventa presto assistente ecclesiastico
dell'Azione cattolica di Crotone, ma nel 1914 viene chiamato alle armi
e, allo scoppio della Grande guerra, avviato al fronte come assistente
spirituale dei combattenti.
Finita la guerra torna a Petilia, vince il concorso
magistrale e insegna nella scuola del paese. Intanto si iscrive alla
facoltà di lettere dell'Università di Napoli e nel 1924 si laurea a
pieni voti. L'anno dopo supera anche il concorso direttivo e diventa
direttore didattico. Dopo qualche anno di servizio a Cropani, nel 1935
diventa direttore didattico del circolo di Petilia
e nel 1953 è promosso ispettore scolastico con sede a Crotone.
Nella primavera del 1957 effettuò una visita ispettiva a
Caccuri, nella mia classe affidata al professore Mario Sperlì. Ricordo
nitidamente quando per accertare il grado di preparazione degli alunni
chiamò alla lavagna il mio amico e compagno Agostino Falbo e gli dettò
la frase " La campagna è tutta verde." Chissà se Agostino
ricorda l'episodio? Poi ci fece cantare tutte le canzoncine che
conoscevamo per accertarsi, ma questo lo capii molti anni dopo, se il
maestro Sperlì ci avesse insegnato per caso Bandiera rossa.
Quando tornai a casa e raccontai della visita di un ispettore vestito da
prete mio nonno mi disvelò la parentela. Attese invano una sua visita,
ma evidentemente i numerosi impegni non glielo consentirono.
Nel 1958 andò in pensione per raggiunti limiti di età e il
vescovo di Crotone Pietro Raimondi lo nominò Monsignore quale Cameriere
Segreto di Sua Santità e Decano del Capitolo di Crotone, mentre il
Presidente della Repubblica lo insignì del titolo di
Commendatore.
Domenico Sisca è autore, fra l'altro, di un pregevole libro su
Petilia Policastro che rappresenta un prezioso contributo alla
storiografia non solo petilina, ma ti tutto il comprensorio crotonese.
‘A
PIGNATELLA
di Peppino Marino

‘Na pignatella
‘e crita smaltata
supra lu focu
vorria tenè.
‘Na corchjiarella
quattru surache
due pampine ‘e lauru
pper addurà.
Vulissa virere
quannu poi vùllari
‘nu pocu ‘e sale
pe’ c’ammentà.
Quannu se còciari
allu focularu
quarsiasi cosa
è cchiu sapurita
pecchì l’amuri
chi si ce mintari
è lu cchiù megliu
re ogni adduru.
E quannu è cotta
‘a minerrella
‘ntra coppa ‘e lignu
vurria mancià,
Nu
pocu è pipe
e d’ogliu santu
corchja ‘e cipulla
gulia ‘e mammà.
Viva la tavula
re lu cafune
àtrica Mc Donald
e fast food.
‘A minerrella
‘e pasta e surache
è ’na delizia
cririti a mia
cu’ ‘nu biccheri
re la Funtana
o ‘e re Pantane
o re Lupiaaaa.
AMICIZIA
di
Peppino Marino

Amicizia è disinteresse;
Amicizia è trepidare per l’altro.
Amicizia è accogliere l’altro;
Amicizia è non irridere l’altro.
Amicizia è mangiare dello stesso pane;
Amicizia è donare se stesso.
E non chiedere nulla in cambio;
E non dire mai: “Io ti sono amico.”
E non dire mai : “ Ho sofferto per
te.”
E non dire mai: “Ho pagato per te.”
Dire solo e sempre: “Ho gioito per
te.”
TERRA MAGICA

Come si fa a non amare questa
terra di Calabria? Nonostante le ferite inferte che sono
purtroppoil
prezzo da pagare alla modernità è sempre stupenda con i suoi
paesaggi variegati, con gli ulivi argentati, la macchia
mediterranea, i calanchi di candida argilla, gli spuntoni di
arenaria e di calcarenite, i torrenti, i ruscelli, le siepi di
mirto e di lentischi, di rosmarino e di lavanda, i fichi
d'India, gli aranci, i limoni, i corbezzoli, il terebinto
e la ginestra e l'orizzonte dove si abbracciano teneramente cielo
e mare. Questa è la Calabria, signori!
LA
NON PIOGGIA A ZIFARELLI
(UN LUOGO SENZA PINETO)
di Peppino Marino

Taci. Varcato il
cancello
non sento alcun suono prodotto da gocce,
ma ascolto le secche foglie che scricchiolano sull’arida terra.
Ascolta, o Emiliano, non Piove sulle arse querce bruciate dal sole,
sul timo inaridito, sui tageti raggrinziti, sul mirto e sui rovi e la
menta,
sull’agave accartocciata; non piove sulla salvia e la malva.
Non piove sui capelli secchi, sfibrati e rassegnati, sui nostri vestiti,
sui gatti, sui salici asciutti, sull’erba bruciata.
Non piove sui nostri pensieri sempre più seri,
che vagan tra guerre e bollette, di gas e di luce
di quest’ anno ch’è sempre più truce
un anno di Vate e di Duce.
CONTAMINAZIONE
AFRO - CALABRA

Riflettevo su quest'angolino della mia casa nel quale, casualmente
si è verificata una "contaminazione artistica" afro -
calabrese in un vano della credenza che ospita due strumenti musicali
etnici di provenienza africana e tre opere di mio padre; una scultura in
legno del celebre affresco del Masaccio La cacciata dei progenitori
dall'Eden che si trova nella Cappella Brancacci nella chiesa di Santa
Maria del Carmine a Firenze, una riproduzione del Mosè di Michelangelo
e un vecchio lume a olio il cui originale è in ottone. Sono solo alcune
delle tante sculture di un uomo umile che per vivere fu costretto a
mettere da parte il suo talento e fare il lavapiatti in un ristorante
svizzero, che solo dopo il pensionamento poté dare estro creativo e che
conserviamo gelosamente. Grazie, papà.
PER
RIDERE UN Pò
LA CASA DEGLI ANIMALI
di P. Marino

Il
gallo vive nella galleria
e l’asino dimora all’Asinara;
mentre il cavallo va in cavalleria,
al pollo toccherà la polleria.
Il cane sta beato alle Canarie
praticamente tutto l’anno in ferie,
il tordo poi finisce nei tordelli
e il gatto va a caccia di altri uccelli.
Il gufo ora abita in un ufo
lo struzzo è alloggiato dentro un pozzo
la capra se la gode a la Capraia
la tartaruga vive sulla playa.
Insomma ogni animale trova casa
e quasi mai gli dànno lo sfratto
per questo alcuni stanno in un anfratto
senza che debban poi pagare un fitto.
‘A
CIOTARELLA ‘E CANALACI
di P. Marino

Si
‘a ‘stu paise c’è ‘na cosa bella
chissa è la cara, amata Ciotarella,
‘nu mascarune ‘e petra ‘na maruca
cu’ ‘na conchiglia cu’ ‘nu
babbaluci
attaccatu allu canale ‘e Canalaci.
‘Nu
tubo ‘e ferru misu ‘ntra la vucca
jettavari re cent’anni l’acqua frisca
chi venia re la valle re lu papa
chi nesciai re ‘ntra ‘na petra cupa.
‘A gente prima si ce rifriscava,
inchjia’ buttiglie, gummili, rancelle
e ancunu puru i panni ce lavava.
Mo puru ‘a Ciotarella s’è stancata
e la vecchjia funtana ormai siccata.
Pregamu tutti i santi e la maronna
chi l’acqua ‘e ‘stu canale sgorga torna
ca s’ ppe’ casu lu viveri è asciuttu
‘stu poveru paise è mortu tuttu.
'U JORNU TUO

All'età di 4 - 5 anni mio padre cominciò a insegnarmi il concetto di
onomastico che nel dialetto caccurese diventa " 'u jornu" (il
giorno): 'u jornu 'e Giuseppe, 'u jornu 'e Franciscu, 'u jornu 'e Maria
etc. Quando papà al mattino mi faceva gli auguri e mi diceva
"Oje è lu jornu tuo" e io, nella mia ingenuità di bambino
pensavo che quel giorno fosse solo mio e di nessun altro sulla terra,
appartenesse solo a me e che per 24 ore ero una specie di regnante al
quale tutti gli abitanti del paese tributavano il loro omaggio. Quando
poi, verso le 11 passava la processione del santo con la banda in testa
perché allora San Giuseppe era ancora un santo di serie A e non gli era
stata inflitta la seconda umiliazione, allora non avevo più dubbi e
pensavo che il festeggiato non fosse il falegname di Nazareth, ma il
figlio del falegname di Caccuri.
Auguroni a tutti i Giuseppe e a tutti i papà del
mondo.
'U BAULLU

Quello
in foto è un vecchio baule, uno dei tanti presenti nelle case dei
nostri nonni nei quali venivano, custoditi, fra l'altro, i
corredi delle ragazze in età da marito che le mamme cominciavano a
preparare già appena finito il puerperio o al massimo lo svezzamento
delle loro figliolette. Decine di tovaglie, lenzuoli, coperte,
tovaglioli, asciugamano di lino ricamati che le future spose non
riuscivano quasi mai a consumare nel corso della loro vita coniugale e
che poi trasferivano alle loro figlie.
Nel mio museo di famiglia ne conservo uno che mio
nonno portò dal West Virginia nel 1919 quando tornò a casa dopo
7 anni di emigrazione con un po' di biancheria e qualche cimelio "mericanu."
L'AZATA
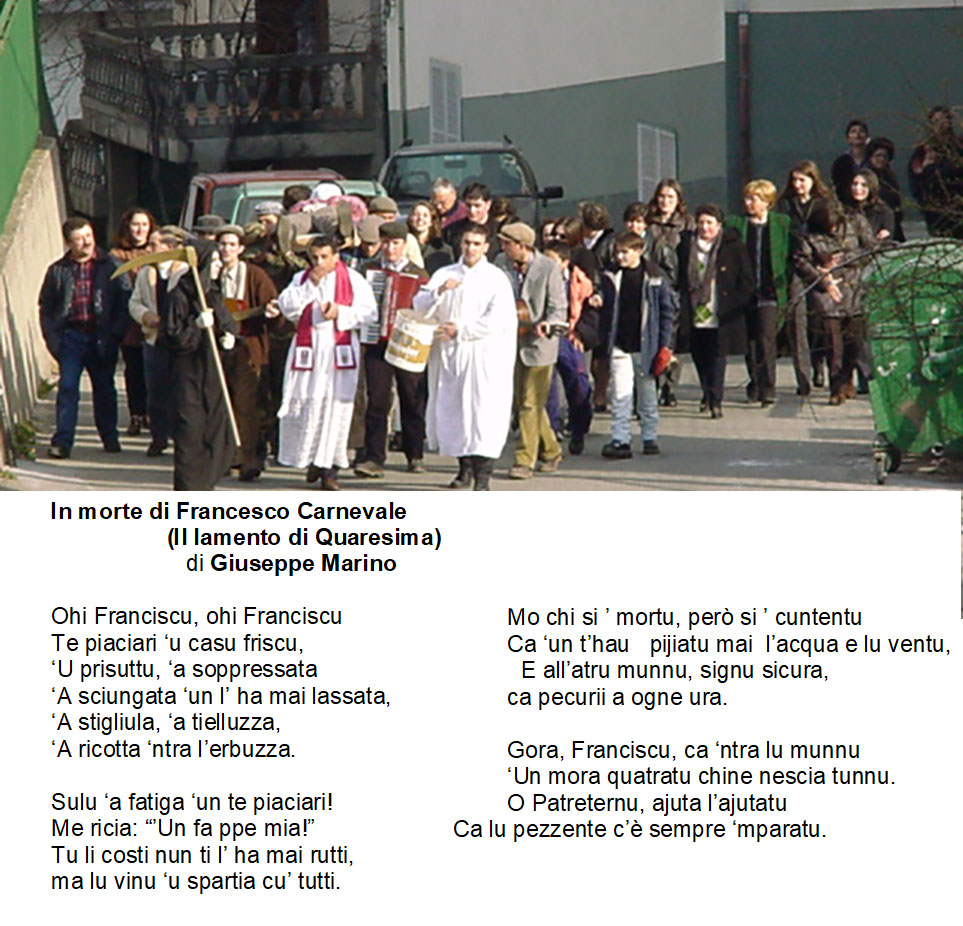
Conclusi i riti funebri per la morte del
nostro amico Francesco Carnevale, filosofo epicureo, maestro di vita,
oggi celebriamo "L'Azata", la festa nella quale "si
alzano", cioè si appendono al chiodo, spiedi, griglie, girarrosto
perché quell'invidiosa di Quaresima, la moglie noiosa del nostro
fulgido eroe, non vuole che, in onore del defunto consorte, per 40
giorni si mangi carne, polpette, salsicce, soppressate, prosciutto e
altri insaccati. In compenso, siccome oggi è il terzo giorno del
rosario del povero Francesco, com'è tradizione, si fa il banchetto per
i partecipanti al mesto rito con 'nu catu 'e pruppette, (un secchio di
polpette) come insegnava il compianto don Giovanni Greco, un bel piatto
di maccheroni conditi col sugo di carne, salsicce, soppressate e ogni
altro ben di Dio.
Carnelevaru è mortu e li maccarruni su' cotti, lu casu
s'ha de grattare, bonu venutu Carnelevari. Però, prima di sederci a
tavola, cantiamo il Lamento di Quaresima che celebra la figura del
grande Maestro che trovate in questa pagina accanto alla foto che
immortala un momento delle esequie.
PARTE E CROCI
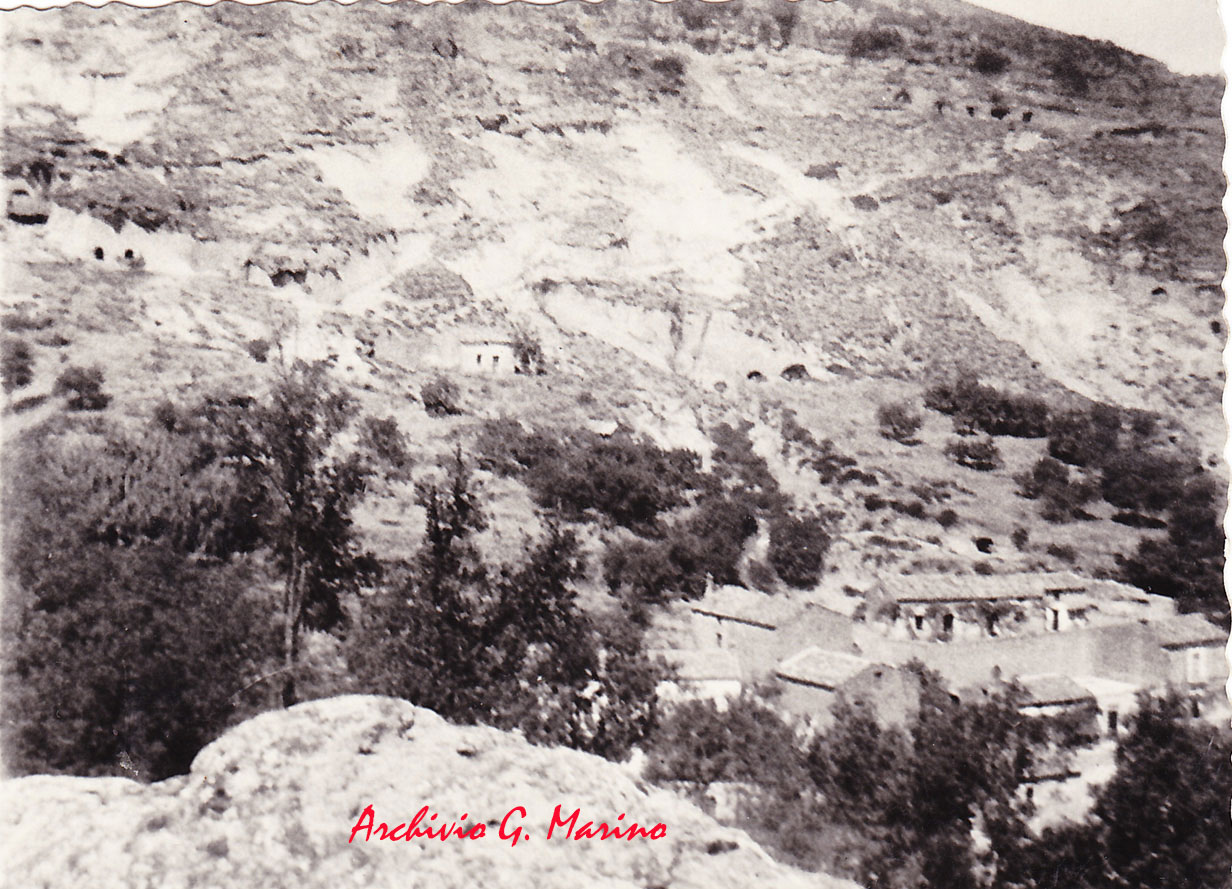
Poiché il presente è triste ci
rifugiamo in un passato più lieto, per certi aspetti eroici quando,
finita la Grande guerra, i combattenti reduci, forti della loro dolorosa
esperienza dalla quale tornavano vincitori come Radames, capirono che
era giunto il momento di uscire dal Medio Evo com'era successo in Russia
qualche anno prima, il momento di rompere il latifondo e di reclamare
condizioni di vita più umane. Così, organizzati nella Lega dei
combattenti reduci guidati da Peppino Gigliotti, don Peppino Pitaro e
Pietro Demare, non solo chiesero che venissero loro concesse le terre
promessa dal governo per spingerli a combattere, ma anche un suolo per
costruirsi una casetta decente e abbandonare grotte e tuguri nei quali
vivevano. A questo punto la baronessa Barracco, per ringraziare gli eroi
o forse per cercare di evitare danni più consistenti al suo patrimonio,
concesse al comune un pezzo di terreno compreso tra il Calvario (i Cruci)
e la limitrofa proprietà dei signori Ambrosio per essere lottizzato e
assegnato ai reduci. Nacque
così il rione Croci. Il terreno, però, bastava appena per i
combattenti e, quando altri artigiani e contadini protestarono chiedendo
anche loro un suolo, il comune mise a disposizione altri lotti ai piedi
della Serra Grande, in gran parte fasce di transumanza, invitandoli a
costruirsi la casa dall'altra "parte". Da qui il nuovo
toponimo "Parte".
NATURA E INGEGNO UMANO

Quando
natura e ingegno umano riescono a convivere, o meglio, l'uomo d'ingegno
costruisce le sue opere, anche imponenti, ma nel rispetto dei luoghi,
possono nascere capolavori come questi. In questo caso l'ingegno umano
è degnamente rappresentato dalla torre dell'architetto Mastrigli
costruita per nascondere un bruttissimo serbatoio di accumulo di acqua
potabile per l'antico palazzo ducale dei Cavalcante che trasformò la
dimora signorile in una specie di castello medioevale, mentre la natura
ha prodotto questi rami e queste foglie secche di quercia che
incorniciano il capolavoro del professionista napoletano del XIX secolo.
Il resto è dovuto a un colpo di fortuna (ma non troppo)
nell'individuare l'angolo giusto e nel programmare lo scatto. Il
risultato mi sembra passabile.
'E
SIRE 'E 'NA VOTA
di Peppino Marino

Vi
regalo quattro versi giusto per rispolverare qualche parola del dialetto
arcaico ormai in disuso.
Quannu
‘a luce ancora ‘un c’era
‘ntra le case fridde e scure
S’allumava la jacchera
pe’ passare ‘nu paru ‘e ure.
‘Ntra i pagliari ‘n menzu i voschi
si nun c’era ‘na lumera
s’appicciavanu i varbaschi,
certe vote ‘n asca ‘e rera.
Cu le menzaporte chiuse
e la casa chjina ‘e fumu
se ‘ncecavari e allu scuru
se cusiari, se gulliava
se facianu le ruselle
se manciavanu le tielle,
poi ‘nzignavanu a cimare
e se jianu a curcare.
RICORDI
DI TEMPI ESALTANTI

Tra le foto che conservo nel mio archivio questa è una di quelle che mi
è più cara perché, oltre a ricordarmi un passato politico e
amministrativo esaltante, ritrae due carissimi amici e un uomo di grande
caratura politica e morale, Rosario Olivo, consigliere regionale della
Calabria, presidente della Regione dal 1987 al 1991, sindaco di
Catanzaro, deputato al Parlamento, sottosegretario al Ministero
dei Lavori Pubblici e della Previdenza nel governo D'Alema e membro
autorevole della Chiesa Cristiana Valdese. Gli amici fraterni sono i
compianti Orlando Girimonte, assessore comunale e Maria Teresa Ligotti, prima
donna eletta nel Consiglio Regionale della Calabria, prestigiosa
dirigente del PCI regionale e provinciale, cofondatrice e dirigente
della Fondazione Enrico Berlinguer di Crotone, comunista leale, aperta
al dialogo, infaticabile, grande amica di Caccuri e dei caccuresi,
sempre presente alle nostre assemblee di partito e alle feste de
l'Unità, spesso insieme ad altri dirigenti prestigiosi come Mario
Sestito, Pasquale Poerio, Maurizio Mesoraca, Fulvio Rurale. Orlando e
Maria Teresa erano per me e mia moglie, più che amici, fratello e
sorella perché a quei tempi i valori dell'amicizia e della comune
militanza valevano più dei legami di sangue.
La foto fu scattata in occasione dell'inaugurazione del
parco di Sant'Andrea con gli annessi campi di tennis e di pallavolo
realizzati dall'amministrazione di sinistra nei primi anni '80. Un
saluto commosso e deferente a Maria Teresa e a Orlando.
RICORDI
DELLA FANCIULLEZZA

Da fanciullo, ogni volta che entravo nel giardino di questo palazzo che
è forse più bello e il più imponente di Caccuri, assieme a quello dei
Cavalcante, al palazzo De Franco di via Buonasera e al palazzo Pitaro di
Sant'Andrea, ero affascinato dalla folta vegetazione, dalle siepi ben
curate, da una gigantesca pianta di glicine abbarbicata a una
impalcatura di ferro che formava una specie di capanna verde coperta da
grappoli di fiori dal colore viola chiaro che spandevano nell'aria un
profumo intenso e gradevolissimo che si mischiava a quello del pane
fresco appena sfornato nel forno dei
proprietari del palazzo all'interno dello stesso giardino, ma,
soprattutto da una voliera e dalla colombaia che si vede anche in questa
foto, purtroppo senza più colombi e col tetto sfondato. Questo
gioiellino mi faceva fantasticare e la mente andava alle palafitte, alla
"vita sospesa" nel mondo e, contemporaneamente, fuori dal
mondo e dai suoi pericoli e immaginavo di abitarci e di vivere
bellissime avventure.
Il palazzo, anch'esso dei De Franco, precisamente del dottore
Vincenzo Maria Raffaele Eugenio De Franco, medico chirurgo, farmacista e
segretario comunale di Caccuri per molti anni, pronipote
dell'arcivescovo di Catanzaro, mons. Raffaele , fu costruito nei
primi anni del Novecento a ridosso del nascente rione Croci.
Dice un antico adagio: "Tutto passa e sfuma e muore,
ma non i ricordi della fanciullezza."
LA
BEFANA CONTRO IL COVID
di Peppino Marino

Filastrocca
della lana,
stanotte arrivava la Befana
volando in cielo di tetto in tetto
quando ogni bimbo dormiva nel letto,
poi s’infilava attraverso i camini
per consegnare i suoi doni ai piccini
e, alla luce fioca dei lumi,
riempiva le calze di dolciumi.
Caramelle, confetti e torroni
Portava in dono ai bimbi buoni,
ma bimbi buoni eran tutti quanti
ché non esistono bimbi birbanti
e a quelli un po’ speciali
portava in dono anche altri regali
cavallucci, balocchi e trenini
per la gioia di grandi e piccini.
Ora però, la vecchia col sacco
di regali ne porta un bel pacco:
quarantene, tamponi, vaccini
per i grandi e per i piccini
green pass usati o taroccati
arti di plastica vaccinati
e a
volare con la mascherina,
quanta fatica per la vecchina.
Che tempi grami, cara Befana,
altro che sacchi e sacchi di doni!,
con un governo che non ha coraggio
è molto difficile evitare il contagio
e se si ci mettono pure i cretini
certo non bastano neanche i vaccini.
Quest’anno ti prego, nelle calze appese
non ti chiediamo regali costosi:
portaci solo un po’ di buonsenso,
di educazione e di prudenza
facci tornare alla vita di un tempo
senza più maschere e distanziamenti
per vivere tutti felici e contenti.
RETI VIARIE E
FERROVIARIE NELLE ZONE INTERNE: UN SOGNO MAI REALIZZATOSI

Il
problema del mancato sviluppo economico del Mezzogiorno e della Calabria
in particolare, una regione che nel 1860 era una delle regioni più
industrializzate della penisola, per la carenza di adeguate
infrastrutture, prime fa tutte le reti viarie e ferroviarie, soprattutto
nelle zone interne, non è nuovo e già all’inizio del XX secolo i
molti politici e istituzioni calabresi cercarono invano e a lungo di
sensibilizzare i vari governi del Regno d’Italia sulla necessità di
realizzare strade e ferrovie degne di un paese civile come si faceva
ormai da quarant’anni al Nord.
Anche le
autorità e i cittadini di Caccuri, a partire dal 1902, si batterono a
lungo per la realizzazione di una ferrovia che collegasse Crotone a
Cosenza, fra l’altro più volte promessa, ma che non vide mai la luce,
cosa che contribuì ad accentuare l'emarginazione e l'abbandono
progressivo delle zone interne. Nel
1902 il sindaco Francesco Maida denunciò, in una delibera del Consiglio
comunale, che " in Calabria la viabilità è ancora allo stato
adamitico, senza che ancora avessero potuto usufruire della più grande
scoperta del secolo, la vaporiera, tutti i nostri paesi che abitano
molti chilometri dalla ferrovia e, per arrivarci, occorre una giornata
intera, nella massima parte attraverso viottoli, burroni e guadando
fiumi perché sforniti di ponti. I prodotti della nostra terra
ubertosissima, per mancanza di viabilità, non possono facilmente
trasportarsi alle più vivine piazze commerciali, quindi la fertilità
della terra non è remunerativa per i nostri contadini i quali,
incalzati dalla miseria ed allettati dal miraggio di una ricchezza per
lo più effimera, sono stati e sono costretti ad emigrare nelle lontane
americhe ove, in mezzo a privazioni e sacrifici inauditi, esplicano la
loro attività ricordando, con le lacrime agli occhi, la patria e il
campicello avito." Una denuncia lucida e accorata, ma che non
produsse nessun effetto. (1) Purtroppo nemmeno i governi repubblicani si
sono preoccupati, in oltre 70 di cercare di alleviare i disagi delle
popolazioni delle zone interne decretando di fatto la morta dei nostri
paesi nei quali ormai nessuno più produce “i prodotti della nostra
ubertosissima terra”, per dirla con le parole del sindaco Maida che,
tanto, non potrebbero, nemmeno oggi, essere agevolmente trasportati.
‘U JIPPARELLU

Non prendetela per una
poesia; è solo uno scherzuccio, un pretesto per rispolverare qualche
vocabolo arcaico scomparso dal nostro parlare quotidiano e omaggiare una
pianta cantata anche da Leopardi che ci vestì per secoli grazie alla
perizia e alla pazienza delle nostre bisnonne. Credo che non vi sarà
difficile tradurla, ma se incontraste qualche difficoltà potete sempre
consultare il dialetto caccurese sul sito L'Isola Amena alla sezione
"Il mio paese - Dialetti".
Chi
nchjiniatu ch’è ’stu guagliunellu
vestutu cu’ ‘nu curtu jipparellu
tessutu cu’ li fili re jinorra
cu’ l’arte antica re le nanne norre
chi la coglìanu pe’ timpe e valluni
'ntra petrarizzi e 'ntra li grattapuni.
Poi la mintìanu ammollu pe’ dui misi
e l’ammaccavanu cu pisanti pisi,
doppu la scarminiavanu cu’ riguardu
mentre la carduliavari al lu cardu
poi la filavanu serute allu 'mparu,
la coglianu allu matassaru
e la tessianu allu vecchiu tilaru.
oppuru 'a gulliavanu cu’ li ferri
e ce confezionavanu i panni norri.
FRA DIAVOLO, UN GRANDE PATRIOTA MERIDIONALE
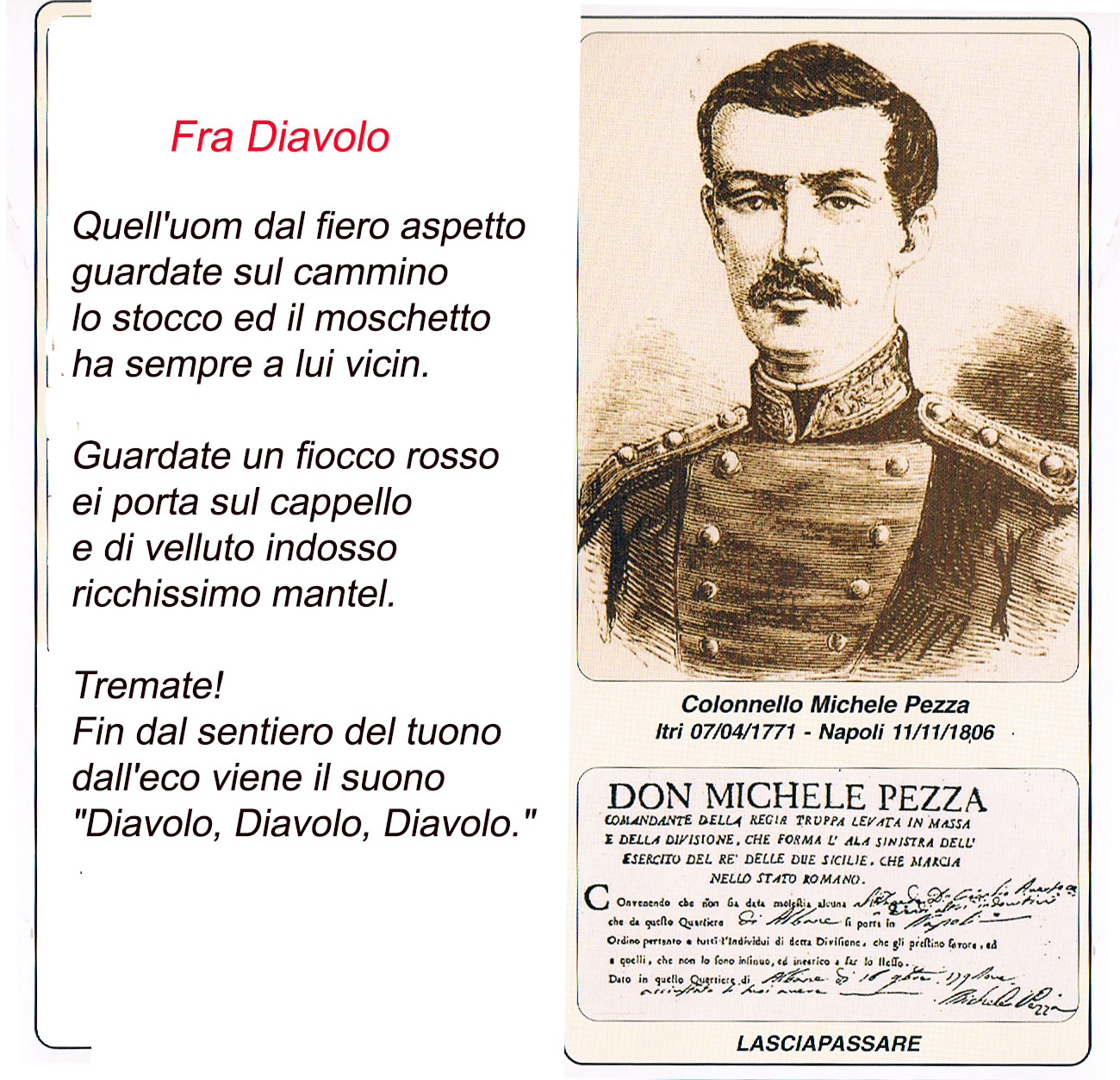
A proposito di briganti, quegli uomini infangati dai francesi come
succede sempre quando una potenza, anzi una prepotenza occupa con la
forza e colonizza un territorio rapinandogli le risorse, schiavizzando e
infangando con aggettivi infami i partigiani (vedi ribelli eritrei per
gli italiani, per esempio, o banditen per i tedeschi durante la
Resistenza), mentre, in molti casi si tratta di eroi, patrioti che
combattono l'invasore, ecco un esempio di eroe, un ex frate, poi
colonnello dell'esercito del Regno delle due Sicilia, nemico acerrimo
dei francesi che nel 1805 occuparono il regno meridionale cacciando i
borbone e mettendo sul trono prima Giuseppe Bonaparte, fratello di
Napoleone e poi il cognato dell'imperatore, locandiere, prete mancato e
poi generale al servizio dell'illustre cognato.
L'eroe in questione, Michele Pezza da Itri, molto
popolare e temuto all'inizio del XIX secolo, è, tuttavia poco
conosciuto dagli italiani o, conosciuto solo in virtù del soprannome di
Fra Diavolo che gli affibbiarono per la sua presunta ferocia e
inafferrabilità e per le sue diaboliche imprese che crearono non pochi
problemi ai terribili e feroci francesi
o per il celebre film commedia con Stan Laurel e Oliver Hardy che
riprende l'opera Fra Diavolo, ou L'hôtellerie de Terracine del
compositore francese Daniel Auber. Una curiosità: da frate Fra Diavolo
visse nel convento di San Giovanni in Fiore e fu accusato di averlo
incendiato. Per capire la grandezza di Michele Pezza giova leggere
cosa scrisse di lui Victor Hugo, figlio
del colonnello Sigismond, appositamente inviato a Napoli per dare la
caccia a Michele Pezza, un nemico giurato, insomma, che
scrisse:”Frà Diavolo personificava quel personaggio tipico, che si
incontra in tutti i paesi invasi dallo straniero, il brigante -
patriota, l’insorto legittimo in lotta contro l’invasore. Egli era
in Italia, ciò che sono stati, in seguito, l’Empecinado in Spagna,
Canaris in Grecia e Abd-el-Kader in Africa !”.
PARODIA
DEL BRIGANTE CACCURESE
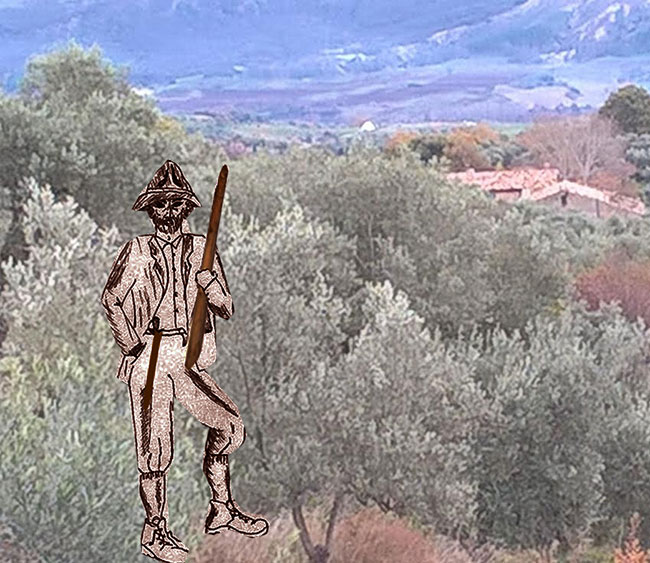
Darsi alla campagna, alla macchia (in dialetto jettare 'ncampagna),
significa darsi al banditismo che è cosa diversa da quello che poi
comunemente veNne definito "brigantaggio" dopo l'occupazione
francese agli inizi dell'Ottocento prima e la conquista piemontese del
Regno delle due Sicilie nel 1860. I "briganti"
criminali, quelli cioè che non si battevano contro gli aggressori, ma
erano animati solo dall'istinto delinquenziale (anche se ci sarebbe
molto da discutere sulle cause che spingevano la povera gente a
delinquere) erano chiamati, infatti, "scorridori di campagna"
e inseriti nelle "liste di fuorbando", cioè dei banditi, dei
catturandi. Col tempo, però questa sottile differenza scomparve e per
le autorità e per la gente comune divennero tutti briganti.
I nostri nonni, forse per sdrammatizzare un po' il problema
o per ironizzare su qualche povero contadino, assai improbabile
brigante, si inventarono questa simpatica parodia del brigante
caccurese.
Ciciarone è jettàtu 'n campàgna Ciciarone
si è dato alla macchia
pe' scupetta 'nu pàlu re vigna per schioppo
ha un palo di sostegno per la vite
pe' curtellu nu sppicchjiu re canna per pugnale
una scheggia di canna
Ciciarone è jettàtu 'n campagna Ciciarone
si è dato alla macchia.
GIOELLI

Gironzolando per le strade del centro storico si possono ancora ammirare
gioiellini come questi che, chissà "quante notti 'e Natale si
ricordano", come dicevano i nostri vecchi per indicare in
lento scorrere dei secoli. Non è vero, come diceva Jimmy Fontana che
"la noia, l'abbandono, il niente" sono la malattia dei piccoli
paesi; a volte, come in questo caso, sono la salvezza. Troppo spesso,
infatti, tesori come questi sono stati dilapidati sull'altare di una
stupida modernità barattando diamanti con cocci di bottiglia. In questo
caso "la noia e l'abbandono" ci danno l'opportunità di vedere
ancora una vecchia porta con la "menzaporta" con la serramenta
"furgiarisca" opera degli antichi fabbri caccuresi. Per la
cronaca siamo all'imbocco del Vincolato in vico II Buonasera. Che ne
dite, un paio di vergate cu' 'na frusta 'e ogliarru su quella mano che
ha imbrattato la finestrella ci starebbero bene?
FIGHETTI
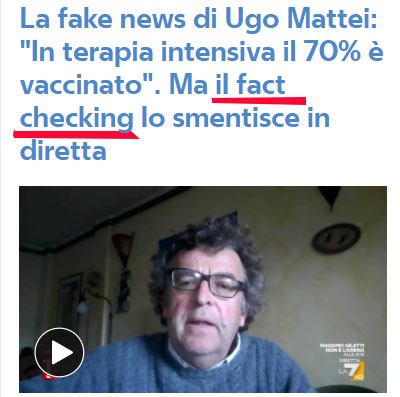
Il professore
Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca e
professore emerito di Storia della lingua italiana e linguistica
italiana all'Università La Sapienza combatte da anni contro i mulini a
vento rappresentati per l'occasione dai fighetti che non perdono mai
l'occasione di fare sfoggio
della loro conoscenza dell'inglese, anche se qualche volta incappano in
qualche clamoroso strafalcione o scambiano il latino per la lingua di
Albione. Recentemente anche il premier Draghi è apparso infastidito
dalla presenza di una abnorme quantità di inglesismi in un discorso che
evidentemente gli aveva preparato qualcuno dei suoi collaboratori, ma i
nostri giornalisti continuano imperterriti nella dismissione della
lingua italiana. Come in questo titolo: potevano usare l'espressione
italiana "verifica dei fatti" che tutti capiscono, anche
quelli che non dispongono di un computer o di uno smartphone, invece no,
"fact checkink" è più figo, vuoi mettere? Poi si lamentano
che la gente non legge i giornali!
Caccuri nel 1897

Ho avuto l'occasione di sottolineare più volte l'importanza storica
della fotografia ed il valore storiografico della stessa. La foto che
commento oggi ne è la dimostrazione più lampante. Si tratta di un
bozzetto di un ignoto artista della fine dell' Ottocento che
raffigura il castello di Caccuri e la Destra visti, più o meno, dal
luogo nel quale negli anni '30 del secolo successivo sarebbe poi sorto
l'edificio della scuola elementare. Tale bozzetto, risalente al 1897,
fu pubblicato sul numero 138 del 1898 della rivista "Le cento città",
edita dalla casa editrice milanese Sonzogno, della quale chi
scrive è in possesso di una rara copia acquistata tempo fa.
Questo prezioso bozzetto, oltre a mostrarci uno splendido
castello a soli dodici anni dalla realizzazione del bastione merlato e
della torre ad opera dell'architetto Adolfo
Mastrigli su commissione di don Guglielmo e donna
Giulia Barracco, proprietari dell'immobile, ci fornisce altri
particolare molto interessanti che cercherò di illustrare qui di
seguito. Intanto il castello, che odora ancora di calce fresca, ci
appare diviso in due corpi. La parte più antica e con l'intonaco più
scuro, a ridosso del vecchio abitato di Caccuri era la vecchia dimora
dei Cavalcanti fatta
edificare dal duca Antonio seniore nella seconda metà del XVII secolo.
C'è poi un secondo corpo, che forma un angolo ottuso con
l'antico palazzo ed è collegato al bastione sul quale si erge la torre.
In questo secondo corpo l'intonaco appare più chiaro forse a
testimonianza del fatto che era stato probabilmente ristrutturato
solo due anni prima. L'imponente costruzione è protetta da quattro
parafulmini le cui aste erano ancora visibili nei primi anni '60 del
secolo scorso; tre sul tetto e una sulla torre. Anche la vecchia
caserma dei carabinieri di via Mergoli era protetta da un parafulmine
costituito da un'asta centrale collegata a quattro funi di acciaio che
scendevano lungo i quatto angoli del fabbricato infilandosi nel suolo.
Accanto
all' asta sulla torre ci pare anche di vedere sventolare una
bandiera, forse un tricolore, vessillo impugnato senza tentennamenti dai
Barracco dopo l'Unità d'Italia quando tre rampolli dell'illustre
famiglia ottennero il laticlavio. Molto nitida anche la rampa sotto la
quale era incassata la vecchia condotta idrica che alimentava il
castello e l'abitato di Caccuri, in uso fino ai primi anni '80 del '900,
rampa che servì anche per il trasporto dei materiali utilizzati per la
realizzazione del bastione e della torre. Purtroppo non si nota la
vecchia via Adua che all'epoca doveva essere solo un sentiero percorso a
piedi dai caccuresi e dai muli e dai cavalli del barone che
venivano rinchiusi nello stallone (attuale casa Talarico).
Continuando l'osservazione di questo prezioso documento
notiamo ben visibili i resti dell'antica cinta muraria nel tratto
compreso tra il Murorotto e la Porta nuova. Nella parte più in basso si
nota anche una specie di torre di avvistamento, probabilmente nel luogo
dove la cinta faceva angolo. Interessanti anche i tetti delle case nella
zona della Porta nuova, molto più inclinati di quelli attuali. Ai
piedi del castello spicca una linea su pali che attraversa il paesaggio
da est a ovest e che potrebbe erroneamente far pensare ad una linea
elettrica. In realtà l'elettricità arrivò a Caccuri solo molti anni
dopo. Quella in questione, invece, è, con molta probabilità, la
linea telegrafica Caccuri Petila Policastro - San Giovanni in
Fiore costruita nel 1877 dal Comune di Caccuri per rompere l'isolamento
del paese e che entrò in funzione del mese di ottobre dello stesso
anno. L'opera era stata deliberata dal consiglio comunale il 30 gennaio
del 1877 sulla base di un finanziamento promesso dalla Deputazione
provinciale e che arrivò, però, solo molti mesi dopo che l'opera era
già stata realizzata. (1)
La direttrice della linea, così come ci lasciano intuire i tre pali che
osserviamo nella foto, ci fa ritenere che la linea Petilia - San
Giovanni passasse più o meno per la località Praci - Acquafredda dove,
probabilmente, si collegava a quella di Caccuri.
Purtroppo questi luoghi
fiabeschi rimasero tali solo fino al 1930.
Poi l'opera di deturpazione ebbe inizio con la costruzione dell'edificio
scolastico che devastò parte del "Petraro", luogo nel quale
era sorto nei secoli uno dei più antichi insediamenti rupestri
della Calabria, fra l'altro abitato fino alla fine del XIX secolo, e
proseguì con altri scempi tra i quali la distruzione dello spuntone
della Mezzaluna). Qualche anno fa, infine, a completare l'opera, fu
realizzata una specie di siepe metallica che nelle intenzioni di chi
l'ha realizzata dovrebbe servire a garantire la sicurezza dei passanti
sulla via Adua, ma che, oltre a non garantire un bel nulla, deturpa
orrendamente quello che era rimasto ancora da deturpare.
Intanto
già verso la fine degli anni '40 del Novecento i Barracco cominciarono
a disinteressarsi dell'antica dimora e dei possedimenti caccuresi che
vendettero agli inizi degli anni '50, parte al comune, parte a privati.
Don Guglielmo e Donna Giulia che erano molto legati, anche
affettivamente, a Caccuri e alla loro dimora, non ebbero figli,
così dopo la loro morte gli eredi vendettero non solo il castello, ma
anche lo splendido parco annesso, il convento e tutte le altre proprietà
caccuresi, ma chi subentrò nel loro possesso, a cominciare dal Comune,
non coltivò, evidentemente, il culto della bellezza estetica.
Giuseppe
Marino
1)
Vedi G. Marino, Caccuri
e la sua storia, Abramo 1983, pagg. 31-32
PER NON DIMENTICARE - I
CRUCI 'E 'NA VOTA
di Peppino Marino
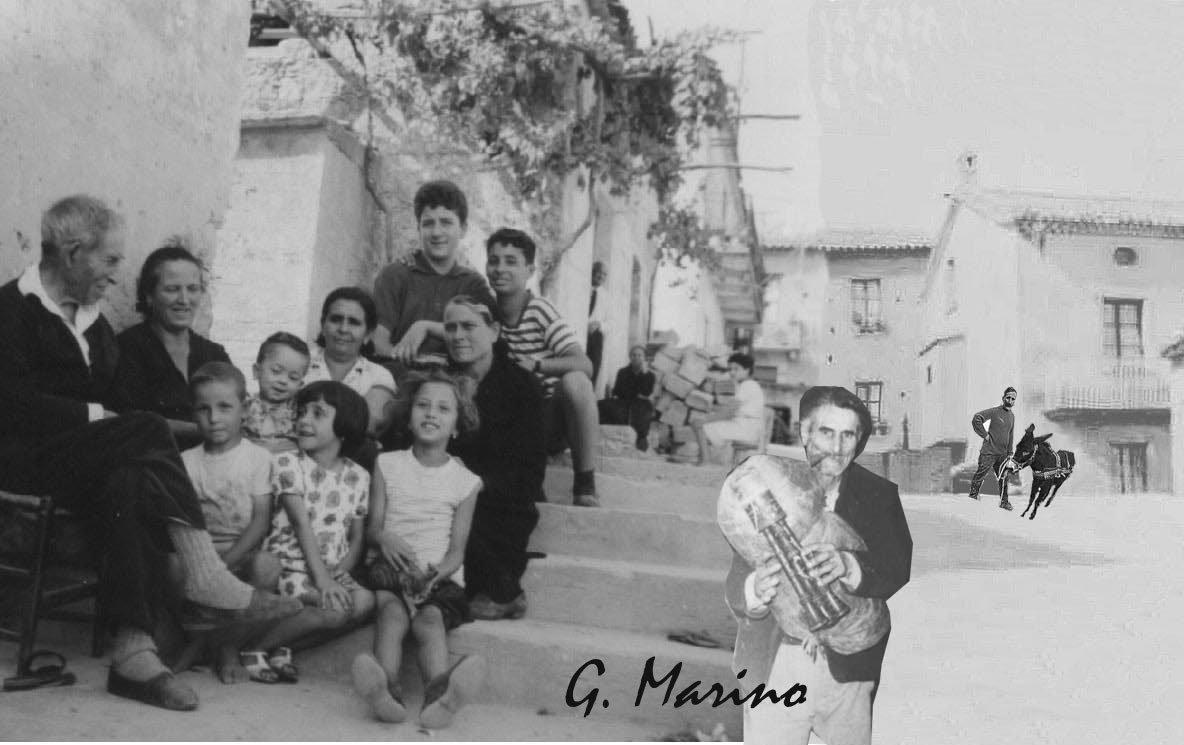
Mo si ti
ne sta bonu, quetu, quetu,
vicinu a
mia, serutu ccà, allu focu,
Luiginè,
mentre te manci ‘e nuci,
te cuntu
cu’ se stava’ ‘ntra li Cruci
versu
‘u cinquantanove, pressappocu.
Mmenzu la
casa ‘e za Maria ‘a Giggia,
sutta lu
pergulatu era seruta,
‘na
vecchiarella: Mariarosa ‘a Muta,
sempre cu
petrannosti e figurelle,
mentre za
Mariantona, affaccennata,
jia de
cca e de llà pe’ vie e vinelle.
C’era
za Filumena la Vituzza,
cu
Marietta, zu Luiciantone,
Matiresa
e Vicenzu e Ciciarone,
mentre
ogni tantu, là, allu viveri
‘ntoppava’
zu Giuvanni re Rizzeri.
Cchjù
supra zu Ruminicu lu mutu;
Stava
serutu ppe’ li fatti sui,
ma nue,
tutti i guaglioni re li Cruci,
ne
rivertianu a ce fare cruci.
Allura zu
Ruminicu s’azava
E puru ca
nun stavari all’imperi,
pijava
‘na bella grasta e cialameri
e, cu la
forza, a nue ni la minava.
Poi nne
curriari appressu, povarellu,
e allura
nue, pe’ ne sarbare a pella
fujianu
n’tru fornu ‘e Nuzziatella
e ni ce
zunmmullavanu a munzellu.
E allura
‘u vecchiarellu, povarellu,
li peri
rrascinannu pe’ l’affannu,
se ricoglìa
alla casa e s’assettava
e tutta
la marmaglia se scialava.
C’era
zu Giggiu cu lu gummulicchjiu,
chi jia a
Larusu all’acqua frisca e bella
mentre
cchjiu supra, za Marasabella
scupava
la casa chjina re rinacchjiu.
A gente
alla Nuzziata picuniava
Nguacciu
la casa e za Marasabbella.
‘a rina
ppe’ se fare ‘a casicella
e cu lu
ciucciu poi la carriava.
Pocu
chhjiù llà c’era la putighella
Re zu
Luigge, ‘u vecchiu re Pizzutu
Vinniari
pasta, zuccaru, e sardella,
sarsa,
sapune, e latte condenzatu.
E nui, li
guagliunelli cannaruti
Volìanu
i formagginu e cicculata
Coglinu i
grigffu a triangulicchjiu
E
Rintintin, Lupettu e autri ancora.
E pe lle
vie quanti belli jochi:
rummulum,
sguiglia, latru e pecurella,
‘u
cannatellu e poi l’ammucciatela,
e alli
buttuni: allu vulu e allu battu.
Quannu
venìa Natale, Ciciarone
ravari
manu alla ciaramella,
e allura,
n’tru paise, pe’ ogni via
sentìa
la festa ed era ‘n’allegria.
Chissi
eranu ‘i Cruci re ‘na vota,
locu re
pace ‘e gioia e allegria;
c’era
miseria, è veru, ma però,
è
meglio, cumu su riddutti mò?
P.S.
Chi ha la mia età o qualche anno di meno ricorderà sicuramente le
persone citate nella poesia, persone splendide, grandissime nella loro
umiltà che avrebbero meritato la penna di Lee Masters o di Pasolini.
IO
PERò L'HE MISE 'NTRU PANARU

Dice il saggio: 'E re mennule chi juranu a jennaru 'un ne minti 'ntru
panaru. E dice male perché anche i saggi a volte dicono fesserie, primo
perché da quando fu introdotto in Italia dai fenici il mandorlo è
sempre fiorito a gennaio, almeno nel Mezzogiorno, secondo perché dopo 4
anni dall'impianto di un mandorlo, non solo "n'he misu 'ntru panaru",
ma ne ho riempito 'na copparella, una provvista non abbondante, ma
sufficiente per toglierci lo sfizio, durante l'anno, di un po' di
cantuccini fatti in casa. i famosi biscotti etruschi. Credetemi, cari
amici, coltivare la terra e piantare alberi conviene, anche quando
l'annata non va tanto bene, perché alla fine " 'E latru e de
latrune, 'a meglia parte è du patrune."
LA SAGGEZZA NEGLI ANTICHI PROVERBI

Quannu ‘u povaru aiuta lu riccu ‘u riavulu si ne sciala! Oggi mi è
tornato alla mente questo nostro antico proverbio. Vi lascio alle vostre
riflessioni.
L'ANTICA
FESTA CACCURESE IN ONORE DI MAIA
di Peppino Marino

Festa dei lavoratori, San Giuseppe Artigiano, “Festa di Maia”: la
ricorrenza del 1° maggio a Caccuri un tempo era un miscuglio politico
– religioso, una occasione nella quale tre culture diverse, quella
laica moderna, quella cattolica e quella pagana, si intrecciavano e si
compenetravano fino a contaminarsi magari inconsapevolmente. Se la
chiesa fa coincidere con la più laica delle feste la celebrazione dello
“sposo di Maria” (che fra l’altro festeggia già il 19 marzo)
nella sua veste di lavoratore (secondo il maestro Profazio fu lui a
fondare il sindacato) ed il sindacato organizza (o meglio, organizzava)
la festa del lavoro, chiesa e sindacato sovrappongono le loro
celebrazioni a quella di un’antichissima festa pagana: quella per
l’arrivo della primavera, dedicata alla dea Maia. Già nell’antica
Roma, nel periodo primaverile, si celebravano numerose feste in onore
della maggiore delle Pleadi, la bellissima figlia di Atlante e di
Pleione amata da Zeus con il quale concepì Ermes, considerata
l’artefice del risveglio primaverile. A Caccuri, evidentemente, questa
antichissima tradizione è rimasta intatta nel corso dei millenni, anche
se, ovviamente, la contaminazione cattolica, l’ha in qualche misura
snaturata per non dire cancellata. Comunque, in ricordo di quella antica
festa pagana, le donne usavano fino a pochi anni fa collocare
sull’architrave dell’uscio delle case un mazzo di fiori (ginestra,
sambuco e di spine di colore giallo) in onore della divinità. A questi
possono aggiungersi altri fiori, con l’accortezza di non far mancare
mai la spina che, secondo un’antica credenza popolare, dovrebbe
accecare i nemici della famiglia che abita in quella casa e, comunque,
proteggere dall’invidia e dal malocchio. Particolare attenzione veniva
posta alla prima persona estranea che metteva piede in casa nel corso
della mattinata: guai se era una persona anziana o, peggio, a lutto!
Rischiava, nella migliore delle ipotesi, di venire cacciata via in malo
modo, se non di peggio. Se entrava in casa di primo mattino un anziano o
una persona in lutto, il presagio era inequivocabile: morte e sciagure
sicure entro la fine dell’anno. Grandi feste e generosi regali,
viceversa, se a varcare per primo la soglia era un ignaro fanciullo,
simbolo di prosperità, salute e lunga vita. Quanta cultura abbiamo
gettato nella pattumiera!
IL
LAVORO è FATICA
di Peppino Marino

Dedicata
agli amici che hanno commentato il post su aia e palmenti
Come
giustamente disse Arturo,
“Più
tempo passa e più il lavoro è duro!”,
e,
ancor più giustamente aggiunse Orlando
“Il
pane si guadagna faticando!”
“Questa
è la vita, sentenziò Giovanni,
si
vive notte e giorno tra gli affanni!”,
talché
rise di gusto Salvatore
che
è sempre stato un gran lavoratore.
“Bene...,
bene...., concluse allora Franca,
resta
assodato che il lavoro stanca:”
“Però,
osservò perplesso Cortellazzi,
se
non lavori, cosa mangi? …….. lazzi?!
ANCHE
LORO CELEBRAVANO LA PASQUA

Nei giorni di festa, come
quello di oggi siamo soliti scambiarci gli auguri con i nostri cari, con
gli amici, con le persone che incontriamo. Usi, consuetudini, riti che
si tramandano nei secoli, immutabili, tranne qualche nuova moda, qualche
contaminazione consumistica che, magari, ci porta a preferire dolci o
piatti che niente hanno a che vedere con la nostra cultura, ma tutto
sommato, continuiamo a fare quello che hanno fatto i nostri padri, le
nostre madri, i nostri nonni i caccuresi di una volta, come quelli in
questa foto che ho avuto la fortuna di conoscere e di stimare. Li
presento a chi non li ha conosciuti con l'ausilio dei numeri:
1) Antonio Manfreda (zu 'Ntone 'e Cerza)
2) Michele Dardani, fratello della medaglia d'argento Giovanni;
3) Peppino Salerno (Cesarino)
4) Domenico Falbo (Micuzzu 'u Vurpu)
5) Carolina Lucente
6) Peppino Gigliotti ('U Dado)
7)Eugenio Pitaro, macellaio
8) Enrico Pasculli
9) Matteo Oliverio
10) Francesco Sperlì, sindaco del paese
11) Guido Iaconis (Guiruzzu).
Un saluto commosso e deferente a
quelli che non sono più con noi.
'A
CHJIANCA 'E GENUZZU PITARO

Ho avuto modo più volte di parlare dei
numerosi esercizi commerciali che costellavano il tratto compreso tra la
Santa Croce e il largo Misericordia negli anni '50 del secolo scorso e
che facevano dell'antico borgo un centro vitale e animato prima che il
lento declino iniziato negli anni '90 lo trasformasse quasi in un paese
fantasma.
Subito dopo il forno Blaconà e prima del bar Caputo, a quei tempi
gestito da Ciccio Pasculli che si avvaleva della collaborazione del
suocero Rosario Catanzaro, ci imbattevamo in questa macelleria di
proprietà di Eugenio Pitaro ('a chjianca 'e Genuzzu), un bugigattolo
nel quale facevano fatica a entrare più di due persone oltre il
titolare, ma che, assieme a quella di Luigi Iacometta al centro di via
Misericordia e a quella di Antonio Gigliotti in largo Misericordia,
adiacente il salone Tallerico, fornivano la carne per la numerosa
popolazione del tempo. Il locale era quello che poi ospitò per molti
anni il bancomat e oggi il punto di informazioni turistiche.
Eugenio era una bravissima persona. Personalmente ne ho un ottimo
ricordo anche perché in anni molto difficili per la mia famiglia ci
fece credito senza problemi consentendo anche a noi di mangiare un po'
di carne come se fossimo pure noi dei signori. Quando dovevamo chiedere
la carne a credito era lui che, amabilmente, ci toglieva dall'imbarazzo
e queste sono cose che non si dimenticano.
LA FAMIGLIA ALLEVATO
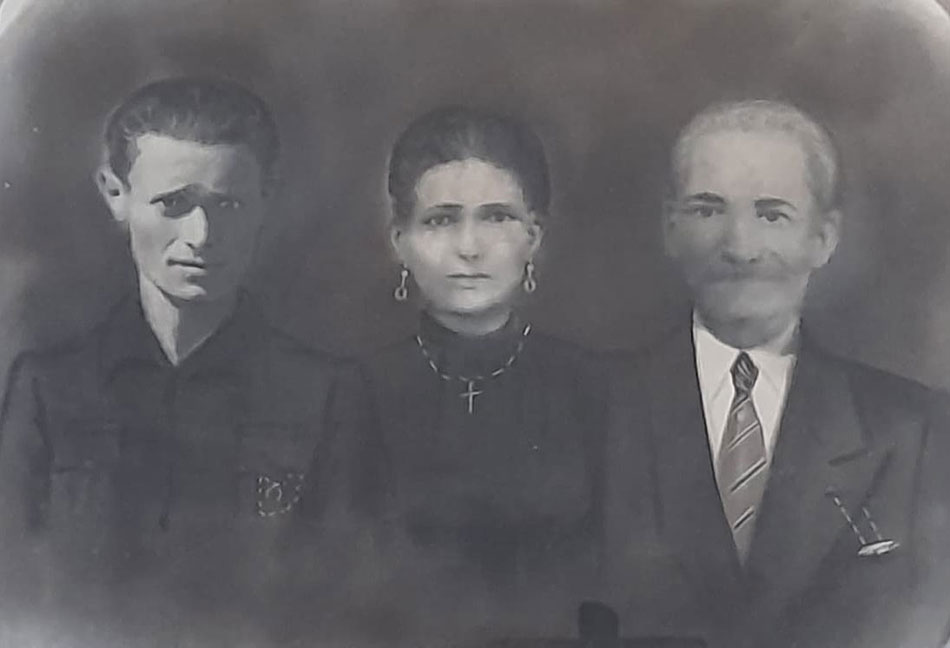
L'amico Peppino
Allevato mi ha fatto pervenire questa interessante foto che ritrae i
nonni, Francesco Allevato e Filomena Leto col figlio Luigi, a sinistra.
Impressionante la somiglianza tra questo ragazzo e il fratello Vincenzo,
padre di Peppino. La famiglia Allevato era una delle tante famiglie
caccuresi divise in vari ceppi e delle quali, se non sbaglio ormai è
rimasta solo quella di Peppino. Un destino comune a molti cognomi un
tempo diffusissimi in paese e oggi scomparsi, come i Peluso, i Procopio,
i De Luca, o la cui presenza è fortemente ridotta come, appunto, gli
Allevato, i Secreto, i Lucente, gli Oliverio. Peccato.
PIETà FILIALE
di Peppino Marino

Nicolino
era appena tornato dall'America: lo si capiva a prima vista dalla
sgargiante giacca gialla, dalla cravatta blu sulla camicia marrone, dal
cappello di lino bianco e dalle scarpe esageratamente a punta;
l'immancabile sigaro in bocca completava il look dell'ennesimo italo americano.
Vent'anni prima, carico di miseria e di speranza con sulle
spalle una elegante "valigia di cartone" era salito su uno dei
tanti bastimenti che solcavano l'oceano diretti nel paradiso di Roosvelt.
E la fortuna era arrivata quasi subito sotto le sembianze di un
compaesano che gli aveva trovato un posto di garzone in una pizzeria di
"Brokkolino".
Nicolino ci aveva dato dentro e già tre anni dopo,
raggranellato qualche dollaro, si era messo in proprio. Gli affari
andavano discretamente e il giovane non aveva dimenticato il vecchio
padre rimasto in Italia e al quale mandava puntualmente qualche soldo.
Tutto andava a gonfie vele quando un brutto giorno il povero vecchio
venne chiamato repentinamente in cielo e dovette abbandonare questa
valle di lacrime. Nicolino ne soffrì terribilmente e da allora non pensò
ad altro che a tornare per un breve periodo al suo paese per far visita
alla tomba del padre.
Venti anni dopo finalmente sbarcò in Italia e, dopo
qualche giorno, giunse al paese. Il momento era arrivato e,
in occasione della festa dei morti, si recò al cimitero. Giunto nel
posto ove presumeva si trovasse la tomba del povero zio Gaetano si mise
a chiamare a gran voce don Pasquale, il vecchio custode del cimitero
perché gliela indicasse. "Don Pasquale, prese a dire nel suo nuovo
idioma, you impara me dove essere tomba my padre?" Il custode, che
a stento aveva decifrato quella tiritera, gli mostrò il tumulo
sotto il quale riposava zu Gaetano e sul quale si reggeva a stento
un piccola croce di ferro, poi tornò alle sue faccende.
Nicolino guardò a lungo la misera sepoltura, ma non
riusciva ad accettare l'idea che li sotto potessero esserci le spoglie
del padre. Passò ancora qualche attimo e richiamò il custode.
"Don Pasquale, Don Pasquale, sorry, my padre non essere qui".
Don Pasquale pazientemente ritornò sul posto e gli indicò
per la seconda volta il tumulo. Nicolino sembrò finalmente convinto e,
mentre una lacrima gli solcava il viso, sistemò un mazzo di fiori sulla
croce. Poi rimase lì a meditare, ma più passavano i minuti, più gli
sembrava impossibile che il padre potesse stare li sotto. "Don
Pasquale, si mise ad urlare per la terza volta Nicolino, my padre non
essere qua!" "Sarà andato un'altra volte al
bar a giocare a carte; non lo perde mai questo viziaccio!"
urlò don Pasquale bestemmiando come un turco, mentre i parenti degli
altri defunti scoppiarono in una fragorosa risata.
SCHERZUCCIO
di Peppino Marino

Questo scherzuccio senza
pretese ha il solo scopo di rispolverare e ricordare a me stesso alcuni
sostantivi del nostro dialetto, alcuni dei quali in disuso da anni. Non
cercateci messaggi occulti, intenti didascalici o moraleggianti che non
trovereste semplicemente perché non ci sono.
C’era
‘nu quatrarellu
‘nu pocu accippatellu
supra ‘nu timparellu
c’avia nu jipparellu
paria ‘nu babbarellu.
Avia ‘nu copparellu,
‘na palettella rutta,
‘ncoppava la terra asciutta
e la mintia ‘ntru coppu.
Passa ‘nu cristarellu
vulannu ‘ntra lu celu,
vira lu guagliunellu
e si ce
fruga ‘ncollu.
Però
‘nu canicellu
zumpa re lu munzellu
‘e terra llà vicinu,
se lanza cu ‘nu lefantu
contra lu malu aggellu
e cu’ ‘nu muzzicune
‘u
jetta ‘ntru grattapune.
E’ sarbu ‘u piccirillu
cuntentu ‘u canicellu
se serari a cullura
e jocari la cura.
'A
SANTA CUCUZZA
di Peppino Marino

“A
cumu canta la Santa cuzza……”. Chi di voi non ha mai sentito questa
espressione dialettale che sta a significare più o meno “a giudicare
dalle apparenze, “da come si presenta la cosa”, da quanto è dato
vedere. Ma da dove ha origine questa curiosa battuta che risale ai tempi
di papa Galeazzo. Si, papa Galezzao! Ah, non cercatelo nell’annuario
dei papi perché non lo troverete. Papa Galezzo, infatti, Caliazzu in
pugliese, è un papa salentino frutto della fantasia popolare, che aveva
un curioso sistema per contare i giorni e individuare quelli festivi
utilizzando semi di zucca e fave conservati all’interno di una zucca
vuota essiccata. Un calendario davvero originale. Secondo
la versione caccurese, però, ‘a santa cuccuzza del papa pugliese,
oltre che come calendario per individuare
i giorni della settimana e le festività mobili, era anche un mezzo per
prevedere il futuro, un oracolo insomma i cui responsi venivano
comunicati alle persone interessate premettendo la formula “A cumu
canta la santa cucuuza.” Insomma uno strumento davvero comodo. A
questo punto ho chiesto anch’io all’oracolo cucurbitaceo:
“Usciremo davvero presto dalla pandemia?” La risposta lapidaria e un
po’ sibillina è stata: “A
cumu canta la santa cucuzza ‘un mi ne chjiura nasu!”
L'ALUNNO
MODELLO

Quando
insegnavo mi piaceva tantissimo scrivere drammi, commediole, sketch come
questo che spero vi regali un po' di buonumore.
Personaggi:
1) Mario
Rossi, alunno modello
2) Il
Maestro
3) Il
Direttore
4) Pierino
5 4
comparse donne
5) 2
comparse uomini.
Scena
unica
Interno
di un'aula arredata con cattedra, lavagna e banchi rigidamente
divisi per sesso. All'apertura del sipario gli alunni sono tutti in
piedi per l'aula e fanno chiasso. All'improvviso entra il maestro e gli alunni
si precipitano ai loro posti. Il maestro li rimprovera aspramente.
Maestro: Discolacci, maleducati,
sempre I soliti! Mai una volta che
vi si possa lasciare soli un momento. (Si siede in cattedra.) Dunque,
vediamo un po’, siete tutti presenti?
Pierino: No, manca Rossi. Gli è morta
la nonna.
Maestro: Un'altra
volta, ma quante nonne ha? Quindici?
Pierino: Io
che ne so? Il padre s'è sposato tre volte.
Tutti
ridono rumorosamente.
Maestro: Silenzio,
mascalzoni. Vi faccio passare io la voglia di
fare
gli spiritosi. Dunque..... oggi
interroghiamo. Spero di
trovarvi preparati....... (rivolto
a Pierino) Tu,
Pierino,
vieni tu.
Pierino
si stiracchia, sbadiglia, si contorce.
Maestro: Sbrigati, pelandrone,
non ho tempo da perdere.
Pierino
si alza e si avvicina alla cattedra.
Maestro: Dunque,
vediamo.........
Si
sente bussare alla porta.
Maestro: Avanti,
Si
apre la porta ed entra il Direttore. Alunni ed
insegnanti scattano in piedi.
Direttore: Buon
giorno, signor Maestro, buon giorno ragazzi.
Alunni
e maestro: Buon giorno, signor Direttore.
Direttore: Seduti, seduti. Bravi ragazzi, vedo che la
vostra è una bella
classe. Bravo, signor Maestro, mi compiaccio! Oggi ho deciso di
farvi una visitina per constatare di
persona l'andamento di questa classe. MI auguro proprio
di trovare alunni seri, degni cittadini della
nostra amata patria, modesti, virtuosi e preparati.
Mentre
il Direttore parta, Pierino disturba e il maestro furtivamente gli tira
le orecchie.
Direttore:
Signor Maestro, Lei mi consente, vero, di interrogare qualcuno
di loro?....
Maestro: Con
grande piacere, pensavo proprio di interrogarli.
Direttore: Bene, grazie, (rivolgendosi
a Pierino) Incominciamo da questo bravo giovanotto.
Pierino
incomincia a fare smorfie mentre il maestro alza gli occhi al cielo.
Direttore: Bene,
caro ragazzo, dimmi un po’, come ti chiami?
Pierino: lo non mi chiamo mai, anche perché poi non
mi rispondo (ride sguaiatamente)
Maestro: (minaccioso) Monellaccio
impertinente!
Direttore: (conciliante) Bene,
vedo che sei abbastanza vispo.
Cominciamo
con la storia romana. Tu conosci
Romolo, vero?
Pierino: E
come no? Ehehhh.
Direttore:
E chi era?
Pierino: Romolo, no.....?
Direttore: Romolo chi?
Pierino: Romolo Il pasticciere. Ieri mi ha regalato due
cannoli.....
Direttore: (scandalizzato). Oddio!
ma no, ..ma no! Beh, passiamo alla geografia.
Dimmi un po’, dove si
trova il Panaro?
Pierino:
Questo è facile. L'ho
visto stamattina nella dispensa.
Direttore: Nella dispensa, ma che dici?
Pierino: Si, zio Pasquale stamattina presto ha raccolto le castagne ah,
ah.
Maestro: (molto
arrabbiato e mollandogli uno scappellotto) ignorante,
maleducato.
Direttore: Uhmmm, nemmeno la
geografia è il tuo forte. Passiamo alla
matematica. Ascoltami bene. TI propongo un
problema facile, facile, ma tu rifletti bene prima di
rispondere....... Allora....
in un cestino ci sono 32
nespole.... Tu ne mangi una ogni
10 minuti... Dopo un'ora
quante nespole ci saranno nel cestino?
Pierino:
(senza riflettere) 32, signor Direttore!
Direttore: Ma come 32, pensaci
bene. Tu ne mangi una ogni dieci
minuti.......
Pierino:
Ma io non le mangio perché le nespole non mi piacciono!
Gli alunni ridono
Maestro:
Monellaccio, impertinente, ti insegno l’ educazione . Vai
a posto,villano!
Direttore:
Lo lasci stare, è un maleducato Ignorante, uno
scansafatiche, un perdigiorno.
Sentiamo qualche altro.
Si avvicina a Mario Ecco,
questo bravo giovanotto. Rivolto
a Mario......... Come
ti chiami?
Mario: Mario,
signor Direttore.
Direttore. Bravo, Mario,
vedo che fai sei un ragazzo educato. Dimmi
un po’, chi era Augusto?
Mario: Caio
Giulio Cesare Ottaviano Augusto, fu II primo
Imperatore romano.
Nacque II 23 settembre del 63
avanti Cristo alle 17,45
minuti primi e dodici secondi
da Atti, sorella di Giulio Cesare
e...................
Direttore: (Interrompendolo) Bravo,
bravo, tu si che sei un ragazzo studioso.
E dimmi ancora, quando partì la spedizione dei
Mille?
Mario: La
spedizione partì da Quarto presso Genova il 6 maggio 1860
alle ore 20,35 minuti e 14 secondi esatti.
Direttore:
Bravo, esatto, che preparazione, quale solida
formazione culturale! Ma passiamo
alla geografia. Mi sapresti
dire quanto è alto iI monte Bianco?
Mario: Niente
di più facile, signor Direttore. E' alto 4.810, tre centimetri
e due millimetri.
Direttore:
Favoloso, stupendo! Bravo, ragazzo mio! Il tuo maestro può
ben essere fiero di un alunno così preparato. Concludiamo
con la matematica. Dunque, tu compri 25 uova
a lire 50 l’una. Quanto spendi?
Mario: (Prontissimo) 1.250
lire, signor Direttore.
Direttore:
Bravo, bravo, bravo! Ecco la vera scienza, la sapienza, la
………
Pierino
: (Ride molto rumorosamente) Ah,
ah, ah, ah....
Maestro:
Basta, briccone, lazzarone.... (Gli da uno
scappellotto)
Direttore: Insomma,
discolaccio, si può sapere cos'hai da ridere?
Pierino: Ah, ah, ah,
sto pensando a quel cretino che vende ancora le uova a cinquanta lire,
ah, ah, ah, ah!.

Saverio
era un contadino povero, così povero da non potersi nemmeno comprare un
paio di scarpe. Quando lo si incontrava di ritorno dal pietroso podere
che gli era stato assegnato dopo la lotta degli ex combattenti, gli
occhi finivano inevitabilmente per fissare l’alluce del piede destro
fasciato da una pezza che fungeva da calza e che faceva capolino dalla
scarpa spuntata. Il vestito liso e consumato, era quanto restava della
divisa con la quale si era congedato alla fine della Grande guerra, un
variopinto assemblaggio di toppe sui ginocchi, sui gomiti e sul sedere.
Ogni mattina si alzava di buonora e si recava alla vigna portandosi
dietro il più piccolo dei figli, Vincenzino, che lo aiutava nei lavori
che la tomolata di terra richiedeva; gli altri, quelli più grandi, o
andavano a giornata nei terreni di don Peppino, o andavano per legna nei
boschi dei dintorni per poi rivenderla a tre soldi la salma.
Il contadino conosceva molto bene il robusto appetito del
figlioletto, nondimeno non poteva che dargli un tozzo di pane di miglio
da sbocconcellare a mezzogiorno. Il problema però era quello di
riuscire ad arrivarci a mezzogiorno.
Verso le dieci passava dalla mulattiera, massaro Michele
che con ironica perfidia gridava al ragazzo:” Vincenzino, Vincenzino
attento ai cani , ehi, guarda, stanno divorando la spesa.” Poi si
allontanava sghignazzando accompagnato dagli improperi e dalle
maledizioni di Saverio contrariato da quello scherzo stupido e crudele
ripetuto quasi tutti i giorni ai danni del povero contadinello affamato.
Alle nove del mattino Vincenzino lottava con i primi
crampi allo stomaco e cominciava la solita litania: “Papà, ho fame,
mangiamo?” Saverio sentiva una stretta al cuore. “Aspetta,
Vincenzino, aspetta. Non abbiamo che pane asciutto; fra un po’ passerà
dalla mulattiera il sardaro, così compriamo quattro alici
salate e mangiamo pane e alici.” “Va bene, papà”, rispondeva
rassegnato il ragazzo. La cosa si ripeteva tre, quattro volte
nel corso della mattinata. E così si arrivava a mezzogiorno. Del
sardaro e delle alici, nemmeno l’ombra e, d’altra parte, anche se
fosse davvero passato, Saverio aveva dimenticato a casa il portafogli.
Allora Vincenzino sbottava: “Papà, io ho una fame da lupo; non me ne
importa niente del sardaro e delle alici, mi accontento del solo pane”
e si precipitava ad aprire la spesa per sbocconcellare il pane di miglio.
Saverio, col cuore a pezzi, sorrideva ripensando a
quell’espediente che gli aveva consentito di tenere a bada la fame del
figlioletto fino a mezzogiorno e sperava di riuscirci anche fino a
sera.
AVOGLIA
'UN FRISCHI!

Quannu 'u ciucciu 'un vo'n acqua, avoglia 'un frischi! Verissimo! Chi di
noi non ha mai "friscatu a 'nu ciuccio" che non aveva nessuna
intenzione di bere? Io l'ho fatto tantissime volte fin quando finalmente
ho aperto gli occhi e serrato le labbra.
Infarto

Don
Nicola era un vecchio buono. Aveva oramai da tempo superato gli
ottant'anni e, da quel giorno, aveva smesso di contarli. Viveva una sua
vita tranquilla godendo e beandosi dei piccoli piaceri che a quell'età
la vita può ancora concedere: la partita a carte, la chiacchierata con
gli amici, un raggio di sole che ti accarezza e ti scalda, la fumatina
nell'inseparabile pipa, compagna fedele di tanti momenti. Ed in quella
splendida giornata di primavera il vecchio li aveva riassaporati tutti
insieme. Uscito di casa verso le nove del mattino, si era recato in
piazza ed aveva giocato a briscola, poi si era seduto sul muretto,
abituale ritrovo degli anziani , per godersi quel tiepido sole e quella
carezzevole brezza che portava fin nel cuore dei paese l'inebriante
profumo degli alberi in fiore e del rosmarino. E, mentre con
gli amici riandava ai bei tempi, alla fatica, ai sacrifici, agli stenti,
ma anche ai canti, ai balli, agli amori, cavò di tasca la pipa e, dopo
averla lentamente e sapientemente caricata, diede fuoco al le polveri
aspirando avidamente quel non proprio profumato incenso. Intanto s'era
già fatto mezzogiorno ed il vegliardo, lasciati gli amici, si avviò
verso casa. A metà strada tolse la pipa di bocca e la ripose, così
come faceva sempre, nella tasca interna della giacca. Era oramai
sull'uscio e la famiglia, seduta al desco, attendeva il suo ingresso in
casa per il pranzo, quando un urlo sovrumano giunse alle orecchie
attonite del figli. "Ahh, gridava il vecchio, il cuore ahh, che
male!". I figli accorsero e lo trovarono accasciato sulla soglia.
"Ahh, figli miei, è finitaaa.... è venutaaa muoio, che dolore!
continuava a lamentarsi don Nicola. I congiunti lo fecero entrare in
casa e lo aiutarono ad adagiarsi sul letto. "Ahhh , figli miei,
gemeva il povero vecchio, è il cuore muoio ahh, ascoltate le
mie ultime volontà." I figli si convinsero che poco restava da
fare e che l'ora del trapasso era arrivata, nondimeno tentarono il
possibile per strapparlo alla morte e, mentre il minore si precipitava a
chiamare il medico, l'altro pensò di togliergli la giacca. Appena
l'ebbe sbottonata, un sottile filo di fumo frammisto al puzzo di tabacco
si diffuse nella stanza. Il giovane dapprima penso che il troppo tabacco
fumato avesse fuso il cuore del vecchio, poi intuì la terribile verità:
gli strappò violentemente la camicia e mise a nudo la piccola ustione
che provocava quell'atroce dolore proprio mentre il fratello entrava
trafelato nella stanza seguito dal medico.
'A Sampugnella

Uno dei motivi per i quali da fanciulli aspettavamo con trepidante ansia
il ferragosto era l'arrivo " 'e
re bancarelle",
le bancarelle dei negozianti di giocattoli allestite nel tratto tra
l'inizio dei Mergoli e quello di via Misericordia subito dopo piazza
Umberto, quella, non quella che ci ostiniamo, a chiamare piazza
Umberto). C'erano si altre attrattive, come ad esempio il mitico tiro a
segno di don Serafino con il bersaglio che quando lo colpivi cadeva
lungo una guida di ferro su una piccola carica di polvere che esplodeva
provocando un simpatico botto o con i fucili a piumini (piccola
freccetta che terminava con un fiocchetto colorato) uno dei quali
una volta, partito dal fucile di un giovane maldestro, si conficcò
nello zigomo del vecchio giostraio facendolo bestemmiare per il dolore,
ma quelle erano attrattive per quelli più grandi, mentre i più piccoli
ci accontentavamo della pistola ad acqua, dello stantuffo o
della sampugnella.
'A sampugnella era
un corista a fiato a una sola nota collegato a un normalissimo
palloncino di quelli che si usano per riempirli di elio e farli librare
in cielo. Il divertimento consisteva nel soffiare nel corista per
gonfiare più che si poteva il palloncino, quindi si lasciava che lo
stesso si sgonfiasse. L'aria uscendo faceva vibrare la lamina del
corista che emetteva una nota lunghissima e monotona. Come passatempo
non era il massimo e forse anche un tantino noioso, ma per la nostra
generazione, che non conosceva la play station e le altre diavolerie,
era il massimo dello spasso. Per dovere di cronaca c'è da dire però,
che nell'attesa del ferragosto e delle sampugnelle,
avevamo scoperto (o meglio lo avevano scoperto i nostri nonni e forse
prima di loro i nonni dei nonni) una sorta di surrogato delll'agognato
strumento utilizzando "i
cannoli" cioè
gli scapi fiorali delle cipolle che andavano in semenza. Soffiandovi
dentro con particolari accorgimenti se ne ricavava un suono simile allo
squillo di una tromba.
'A
JOCCA

" Me para ca se vo' parare jocca" esclamava
mia madre quando una gallina, col suo comportamento insolito,
manifestava il suo "desiderio di maternità".
Allora mamma si affrettava a prepararle il nido contenente un
discreto numero (sempre dispari) di uova che la chioccia si
affrettava pazientemente a covare. Quindi anche per me iniziava
un'attesa impaziente che durava fino a quando le uova non cominciavano a
schiudersi e i pulcini completavano l'opera liberandosi del
guscio. Qualche volta capitava che fra le uova ve ne fosse uno "cuvatusu"
cioè non fecondato dallo sperma del gallo, destinato fatalmente a
marcire sotto la chioccia per cui dovevamo sorbirci il suo
pestilenziale odore. Ogni volta che la chioccia
si prendeva una breve pausa allontanandosi per qualche attimo dal nido
correvo a esaminare attentamente le uova nella speranza di scorgere
qualche segno di vita. Poi, quando la chioccia e la covata si
mettevano in moto razzolando nel piccolo cortile di casa nostra, la
seguivo a prudente distanza perché la neo mamma, temendo che volessi
far male ai piccoli, centuplicava la sua aggressività. Oggi anche da
noi è difficile trovare qualcuno che allevi ancora galline e chi lo fa
le compra già quasi adulte, di quelle nate nelle incubatrici.
Insomma una sorta di fecondazione assistita. Per le galline non si
applica la legge 40 e la chiesa non è contraria alla riproduzione dei
polli con metodi artificiali. Almeno per ora. Addio vecchia,
nevrotica, amata jocca!
FOGLIE
D'ULIVO ALLA VITTORIA

La fantasia in cucina è fondamentale perché ti ispira e ti consente di
preparare eccellenze come queste. Un buon piatto deve riuscire a
deliziare tre dei nostri sensi: il gusto, l'odorato, ma anche la vista
è questo ci riesce in pieno. Questa volta il merito è tutto di mia
moglie che se lo è inventato, dice lei, in una notte insonne. Così
ieri, munito di guanti, mi ha fatto raccogliere una verdura che spesso
maledico quando mi capita di urtarla accidentalmente e che abbiamo
lessato, frullato e impastato con una eccellente semola di grano
duro italiano, assolutamente privo di glisofato. Quindi abbiamo
modellato la pasta ricavandone un bel po' di "foglie di ulivo"
che oggi ha lessato e mantecato in una salsa di salsiccia calabrese
fresca e champignon. Il risultato è quello che vedete in foto. E non è
tutto, ma il resto ve lo racconterò un'altra volta.
Ah, dimenticavo: un avviso a quelli che ti fanno pagare un uovo alla
coque 40 euro: non ci provate, questo piatto è brevettato.
'A
SPISA
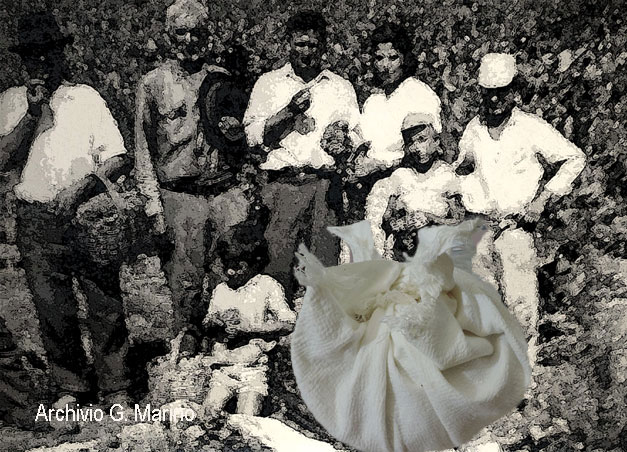
Oggi vi racconto una novella triste ma che dovrebbero leggere tutti e
meditare su cosa siamo oggi, cosa eravamo e cosa rischiamo di tornare a
essere in questo mondo globalizzato e col trionfo del neoliberismo più
becero.
Da parecchi giorni il sole
dardeggiava alto nel cielo ed i suoi raggi infuocati inondavano di luce
la campagna assordata dal frinire ossessionante delle cicale. Le messi,
copiose e biondeggianti, ondeggiavano lievemente ad ogni alito di
brezza: era oramai tempo di mietitura.
Un mattino all'alba una lunga teoria di uomini curvi sotto
il peso dei loro fardelli, asciutti e grinzosi come l'uva passa, col
volto segnato dagli stenti e dalla fame, si avviava ai campi del barone.
Sul braccio ricurvo ognuno aveva la sua falce foderata di stracci e la
mano, già inguainata nei cannelli, stringeva un tovagliolo di lino
bianco i cui quattro angoli annodati formavano una rudimentale bisaccia
contenente la "spesa” il magro cibo della giornata. Erano spese
povere: un tozzo di pane, una fetta di lardo, un pugno di olive secche,
un pomodoro costituivano il pranzo dei più ricchi, di quelli che
potevano orgogliosamente mangiare in gruppo ostentando tanta fortuna;
gli altri, i poveri, a mezzogiorno, si allontanavano con un pretesto
mentre il caporale bestemmiava come un turco che " non ne poteva più
di quella vita grama: tutti i giorni sempre e solo caciocavallo e
uova!"
Nicola era uno di quest' ultimi. Onesto lavoratore
con moglie, tre figlie femmine ed una nidiata di marmocchi che gli
succhiavano fin l'ultima goccia di sangue, disfatto dalla malaria,
mostrava molti di più dei suoi 47 anni. Nessuno lo aveva mai visto
mangiare in gruppo: a mezzogiorno anche lui prendeva la sua spesa e si
allontanava per i campi. Nessuno gli andava dietro, nessuno osava
spiarlo, tanta era la soggezione che incuteva la sua figura taciturna.
Quella mattina la
sua spesa era più voluminosa del solito e Nicola faceva quasi fatica a
portarla. Giunto nel campo cercò un arbusto per appendervela, così
come facevano tutti; i cani, infatti, più affamati dei loro padroni,
frugavano disperatamente dappertutto alla ricerca di cibo. Appeso il
fardello ad un ramo di pruno, si mise a lavorare.
Verso le dieci un
cane si intrufolò furtivamente nel campo e strisciò acquattato fino
all'arbusto. Vide la spesa e cercò di afferrarla. Spiccò un salto, un
secondo, un terzo; finalmente urtò col muso il fardello che prese ad
ondeggiare. Il rametto del pruno scricchiolò, si spezzò. La spesa
cadendo colpì la schiena del cane che prese a guaire
pietosamente fuggendo nei campi. I nodi del tovagliolo si sciolsero ed
una bella pietra bianca e liscia comparve in mezzo al grano.
Gli uomini scoppiarono in una fragorosa risata, ma non
fecero in tempo a vedere il volto di Nicola rigato di lacrime.
L'ARGUZIA
E LA BONOMIA E LE BURLE DI EUGENIO MELE
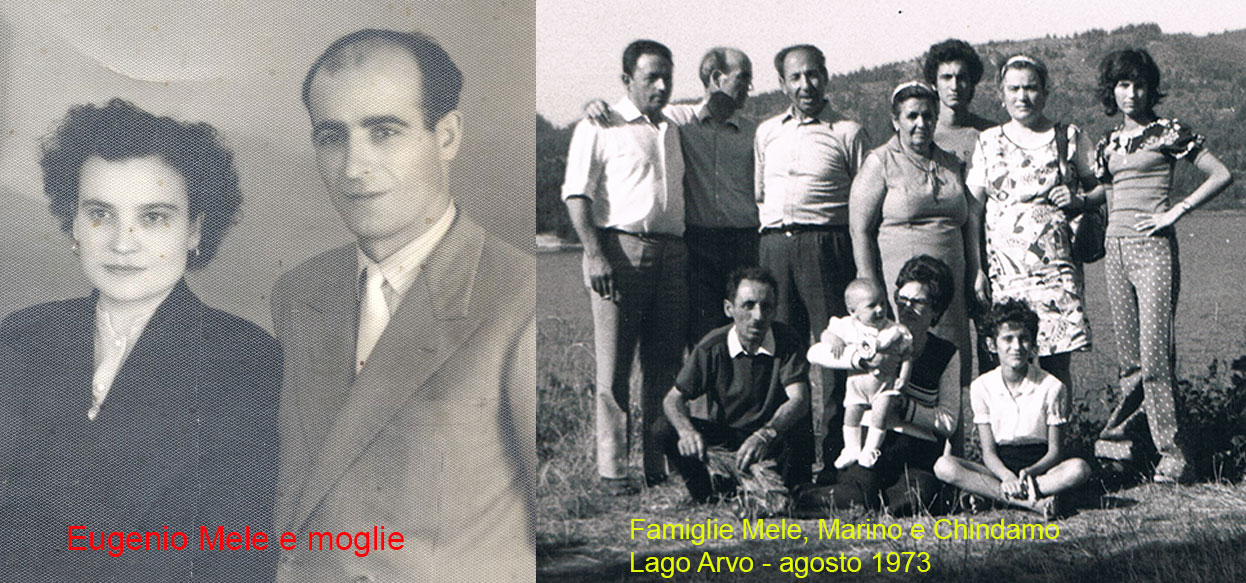
Zio Vincenzo Chindamo ed Eugenio Mele, due ragazzi nati nei primi
anni 20 nel rione Croci, all’epoca quattro case costruite solo 5 anni
prima, erano fraterni amici e compagni di giochi. Il primo abitava
in via Vittorio Veneto, il secondo nella parallela via Sabotino, ma le
abitazioni erano dirimpettaie. Difficile incontrare due amici più
affiatati di loro.
Ancora
fanciulli furono messi a lavorare dai loro genitori poveri: Vincenzo
faceva il contadinello, mentre Eugenio pascolava i capretti. Gli animali
erano giovani e agili e non era facile tenerli a bada per cui Eugenio,
dimostrandosi un genio precoce, ammaccava loro le zampe con una pietra
costringendoli a starsene buoni senza farlo dannare.
Ancora
ragazzi, furono separati dagli eventi: Vincenzo fu chiamato alle armi e
mandato in Grecia dove, dopo l’armistizio fu catturato dai tedeschi e
internato in un campo di lavoro in Germania, Eugenio si arruolò
nell’Arma dei carabinieri, sposò una ragazza caccurese e cominciò a
spostarsi per la Penisola fin quando si stabilì definitivamente a Salò.
Si ritrovarono dopo anni quando Vincenzo, che intanto si era trasferito
a Merano, ed Eugenio capitarono d’estate a Caccuri e da allora
ristabilirono i contatti.
Non
li ho mai sentiti chiamarsi per nome: per Eugenio zio Vincenzo era il
Negus, un soprannome che gli avevano affibbiato per il colore scuro
tipico dei terroni, invece Eugenio per zio Vincenzo era “Grecuzzu”
che era sinonimo di “stortu”, cioè di persona che vuole avere
sempre ragione e imporre la sua visione delle cose, ma credo, anzi ne
sono sicuro, che lo zio lo chiamasse così, non
tanto per il carattere dell’amico che era amabile, ma per
l’assonanza col nome Genuzzu che in caccurese è il diminutivo di
Eugenio.
‘U
Negus e Grecuzzu, erano comunque inseparabili, come due gemelli, come
Castore e Polluce, come Oto
ed Efialte, Achille e Patroclo ed erano complementari: Eugenio aveva un
grande senso dell’ironia che difettava a mio zio, era un grandissimo
esperto di funghi e un ottimo cuoco, ma pur avendo due patenti, quella
civile e quella militare, era assolutamente negato per la guida, cosa
che odiava, per cui mio zio tra i due era l’autista che lo scarrozzava
per i dintorni di Caccuri. Le escursioni erano l’occasione per Eugenio
per raccogliere pregevoli funghi sconosciuti anche al più esperto
micologo che egli cucinava poi con grande perizia degna dei più grandi
chef. Impressionava non solo la stupefacente conoscenza di ogni specie
di fungo commestibili o no e te ne diceva anche il nome scientifico, ma l'abilità nello scovarli in ogni
stagione, col freddo o col caldo torrido, col sole, con la pioggia o con
la neve, negli acquitrini e nei terreni aridi. Gli piaceva
tantissimo cucinare squisiti manicaretti, per niente mangiare e si vedeva!, con quel suo
fisico asciutto, quella figura smilza e agile.
Eugenio,
oltre a essere una persona simpaticissima, amabile, pacata, garbata, era
intelligentissimo, astuto, una vera volpe, dotato di un’arguzia
proverbiale. Oltre i funghi e la cucina, aveva una terza passione: gli
scherzi, le burle delle quali erano solitamente vittime i suoi
commilitoni, ma anche altri amici. Di uno di questi scherzi ne pagò le
conseguenze un povero carabiniere suo subordinato. Era il primo aprile e
il nostro di nascosto, confezionò un pacco con qualcosa che avvolse
accuratamente nella carta, poi ci appiccicò un indirizzo, chiamò il
giovane militare e lo spedì all’ufficio postale distante qualche
centinaio di metri spiegandogli che l’involucro conteneva una batteria
per una jeep che dovevano mandare alla caserma di un paese della
provincia. Il ragazzo si caricò il fardello e sbuffando e imprecando
per la fatica, si fece la strada fino alle poste con quel pesante
involucro.
Appena
uscito, l’astuto Eugenio chiamo al telefono il dirigente delle poste
spiegandogli che si sarebbe presentato un carabiniere per spedire un
pacco che stavano per mandare erroneamente ad altra caserma, pregandolo
di rimandarlo indietro. Quando il povero ragazzo, sudato, con le braccia
indolenzite si senti comunicare che avrebbe dovuto riportare indietro il
pacco, si sentì perso, ma il dovere era dovere e non vi si poteva
sottrarre: Così riprese la strada barcollando per la stanchezza, ma
quando arrivò nel cortile della caserma, inciampò e il pacco gli cadde
a terra. Preoccupato di aver combinato un guaio, si affrettò a
verificare l’integrità del contenuto e fu allora che gli scappò una
imprecazione e una bestemmia quando vide che il pacco conteneva vecchi
mattoni pieni. Ma la burla più bella fu forse quella che giocò a un
ragazzo caccurese con la passione per il canto.
Era
una serata estiva e, verso le 10 di sera, Eugenio stava rientrando a
casa dal centro storico. Arrivato in piazza fu salutato cerimoniosamente
da un gruppo di giovani che lo conoscevano benissimo e che lui conosceva
altrettanto bene.
-
Buona
sera, professore, ci scusi, ma dovremmo chiederle un favore.
Sentendosi chiamare professore rimase un po’ sorpreso, ma una volpe è
una volpe per cui stette al gioco.
-
“Professore,
continuarono quei figli di buona donna, c’è questo ragazzo che viene
da fuori che ha la passione per il canto e vorrebbe diventare un
cantante. Abbiamo pensato che un direttore d’orchestra, un grande
maestro di musica come lei potrebbe fargli un provino e dargli qualche
consiglio.”
L’imbeccata era perfetta; ora sapeva come muoversi e come cucinarsi il
malcapitato.
- Ragazzi esordì, è tardi e qui in piazza potremmo disturbare la gente
che dorme nelle case vicine. Spostiamoci alla Santa Croce, così non
disturbiamo nessuno.
Allora il gruppo si portò ai piedi della croce dei Passionisti e qui il
“maestro” chiese al ragazzo di cantare una canzone.
La voce è discreta, disse dopo che il ragazzo si era esibito
mettendocela tutta, ma sento che c’è qualcosa che la blocca un po’,
un problema di diaframma forse, bisognerebbe fare una prova.
-
Ditemi quello che posso fare, chiese ansioso il giovane cantante.
- Eugenio conosceva un ragazzo del gruppo e sapeva che era
velocissimo nella corsa per cui lo pregò di collaborare, cosa che fece
volentieri essendo uno dei “compari.”
-
Fatti una corsa veloce con Vincenzo da qui alla casa di Gelsomina
e ritorno e appena arrivi mettiti subito a cantare la stessa canzone; questo è
l’unico modo per sbloccare il diaframma.
- I due partirono come una freccia lungo la leggera salita e dopo
poco più di un minuto erano di ritorno. Il ragazzo cercò inutilmente
di cantare, ma il fiato non gli usciva avendolo lasciato tutto per
strada.
- Mi dispiace, ma non hai le qualità per diventare un cantante,
sentenziò l’improvvisato discepolo di Euterpe stroncando la carriera
dell’aspirante cantante, mentre "quelle scuma ‘e cancarena”
degli amici se la ridevano sotto i baffi.
- Qualche
giorno dopo il ragazzo, caccurese, ma che viveva all’estero, venne a
conoscer la vera identità di Eugenio e a sapere che non era un maestro
di musica, ma un appuntato dei carabinieri, fra l’altro suo lontano
parente e la prese a ridere.
Da quel giorno, quando lo incontrava, lo chiamava scherzosamente
“maestro”, lo invitava a bere qualcosa e chiacchierava amabilmente con uno che gli aveva
“stroncato la carriera.”
-
FILASTROCCA
PESSIMISTA

Filastrocca
dall’interno,
eccoci ormai in pieno inverno,
con i monti lontani innevati
e noi ancora carcerati.
Chiusi in casa per la pandemia,
non c’è nessuno più per la via,
anche se, invero, i nostri paesi
non sono morti da pochi mesi.
Case vuote ormai da anni,
tanta angoscia e tanti affanni,
usci sbarrati, spenti i camini
non ricordiamo cosa sono i vicini
perché scomparsi ormai da una vita
il che ci procura una pena infinita.
Le nostre strade son sempre deserte,
non si vedono mai porte aperte
ed il distanziamento sociale
per noi è una cosa così naturale
che non ci badiamo, non è un assillo
perché da anni ci abbiam fatto il callo.
Così l’inverno ci pesa davvero
ed il futuro ci sembra più nero,
più della merla che in questi giorni
se ne sta presso camini e dintorni.
Ma che ci fa presso un fumaiolo
che non fa fumo, che non dà calore
perché lì sotto il suo focolare,
spento da anni non può fumare
può solo piangere e ricordare
tempi felici, gente giuliva
che attorno al fuoco la sera si riuniva
e che oggi abita in mondi lontani
e noi siam soli come poveri cani.
'A
SCIRUBETTA

Oggi, finalmente, ho potuto
prepararmi un'eccellente scirubetta. 'A scirubetta è un gelato "casarulu",
ovvero fatto in casa con neve fresca e mosto cotto. Il nome dialettale
deriva dall'arabo sciorbet, che in italiano diventa sorbetto. Beh,
direte voi, cos'ha di tanto speciale la tua scirubetta? Vengo e mi
spiego, come si diceva una volta. Intanto è fatta con neve di Gimmella,
un posto per il quale, dopo l'abbandono di Fantino, il quasi
spopolamento di Acquafredda e l'abbandono delle attività boschive,
passano, quando va bene, un paio di macchine al giorno, quindi
assolutamente incontaminato, e poi, invece del tradizionale mosto cotto
abbiamo utilizzato il brodo di giuggiole di Zifarelli che ci ha mandato
letteralmente in brodo di giuggiole. Credo che, oltre alle solite
attività, mi trasformerò anche in "nivaru." Devo solo
trovare il luogo adatto per la conserva e la paglia.
BIZZARRIE
DELLA NATURA

A volte la natura è capace di
bizzarrie come queste due strane arance di San Biagio, soprattutto
quella a destra. Chissà per quale misterioso motivo a un certo punto un
gruppo di cellule impazzisce e rompe l'ordine prestabilito dando luogo a
questi strani fenomeni che si verificano anche negli animali e nell'uomo
stesso perché comunque la si rigiri, uomini, animali e vegetali siamo
tutti esser viventi, creature, come dicono i credenti o prodotto
dell'evoluzione secondo non credenti. Se volete divertitevi a dare
un nome a queste forme.
FEDELI BIRICHINI
di Peppino Marino

Nella
bacheca di una chiesa, evidentemente frequentata da parrocchiani un
po’ indisciplinati, erano affissi i seguenti numerosi cartelli.
Sul primo c’era scritto: “Si prega di fare
silenzio”, su un altro “Si prega di non accendere candele o ceri”
e poi ancora: “Si prega di spegnere i cellulari”, “Si prega
di non attaccare il chewingum sotto la spalliera dell’
inginocchiatoio” e infine quello con l’appello più accorato che la
diceva tutta sulla devozione dei fedeli: “Si prega di
pregare.”
ACCADDE DOMANI: FONDATA LA SOCIETà
CICCO SIMONETTA
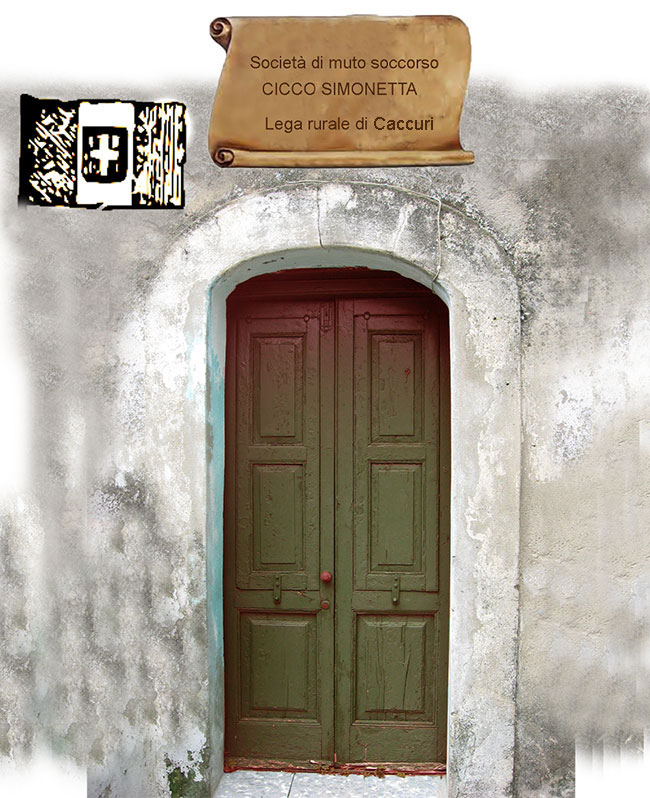
Il 31 dicembre del 1905 i grandi proprietari
terrieri di Caccuri fondarono la Società di Mutuo soccorso Cicco
Simonetta per coalizzarsi e difendere i loro interessi minacciati dalla
nascita della
Cassa nazionale di previdenza
per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai , l'antenata
dell'INPS che
incomincia a estendere il sistema di previdenza prima ai dipendenti
pubblici e ai militari, poi, col governo Pelloux e quello di Vittorio
Emanuele Orlando nel 1919 anche
ai dipendenti di tutte le altre aziende.
I
braccianti e gli altri lavoratori caccuresi risposero, circa un anno
dopo, il 12 settembre del 1906, fondando un altra società
di mutuo soccorso, la Pensiero e Parola, dopo la nascita, qualche
mese prima, della Confederazione Generale del Lavoro, l'antenata della
CGIL a testimonianza, che, già all'inizio del secolo scorso Caccuri era
un paese politicizzato e all'avanguardia nel quale, a differenza dei
giorni nostri, c'erano partiti e sindacati organizzati.
LA
BEFANA AL TEMPO DEL COVID
di Peppino Marino

Filastrocca della lana,
un tempo arrivava la Befana
volando in cielo di tetto in tetto
quando ogni bimbo dormiva nel letto,
poi s’infilava attraverso i camini
per consegnare i suoi doni ai piccini
e, alla luce fioca dei lumi,
riempiva le calze di dolciumi.
Caramelle, confetti e torroni
Portava in dono ai bimbi buoni,
ma bimbi buoni eran tutti quanti
ché non esistono bimbi birbanti
e a quelli che erano un po’ speciali
portava in dono anche altri regali:
cavallucci, balocchi e trenini
per la gioia di grandi e piccini.
Ora però, la vecchia col sacco
di altri regali ci porta un bel pacco:
Covid, crisi e patimenti,
lockdown e distanziamenti,
mascherine appiccicate sui musi
bar, parrucchieri e locali chiusi.
Tanti contagi, tanti malati,
e tanti ancora ricoverati.
Quanto ci soffre or la vecchina
volando nel cielo con la mascherina
ma più soffre ancora vedendo la gente
comportarsi da demente
mentre s’assembra, contesta, protesta
per il presunto scippo di una festa
per cui ha deciso: non doni ai bambini,
ma per quest’anno solo vaccini,
anche se tanti son già a sbraitare
che non si faranno vaccinare
perché non sono ancor bene testati,
meglio rischiare di finire intubati.
Cara Befana, aggiungi un vaccino
per questo vecchio contadino
che si è stufato ogni mattina
di indossare la mascherina
anche solo per andare in campagna
mentre la gente protesta e mugugna.
Portalo presto ché non resisto
e te lo giuro incrociando le dita
te ne sarò grato per tutta la vita.
‘ A FOCERA
di Peppino Marino

Quest'anno ci è stata tolta da questo maledetto virus, ma cerco di
farvela rivivere, soprattutto a chi vive lontano e ha più o meno la mia
età o qualche anno di più, attraverso questo mio racconto.
Ligne, ligne allu santu Bomminu!” Il grido gioioso riecheggiava
nel paese ripetuto, porta a porta, dai monelli, ma anche dai giovani
ciucciari, (1) mentre altri, più grandi, si avviavano verso la
Portanova con gli asini carichi di legna per scaricarla sul sagrato
della chiesa. La gente si affacciava sull’uscio e indicava ‘u
zippune (2) o la zomma (3) che intendeva donare al Bambino Gesù
perché, appena nato, potesse trovare un bel focherello per
scaldarsi e vincere i rigori del freddo ai quali lo sottoponevano la
stagione e la condizione di povertà che lo costringeva a nascere in
una stalla. Ricevuto l’assenso, i ragazzi mettevano il ciocco
sulla carriola, l’accatastavano in un cantuccio per essere
caricato sul dorso del somaro e riprendevano il giro. Anche zu
‘Ntone aggiogava i buoi per trascinare, girando dalla piazza e per
via Buonasera, il tronco di quercia che don Vincenzo donava alla
chiesa ogni anno o quello di gelso, dono di don Antonio. Dopo un
paio di giorni di alacre lavoro, il piazzale della chiesa era invaso
da cataste di legna tanto che, salendo da via Buonasera la rampa di
scale che sbuca sul sagrato, ci si trovava davanti un vero e proprio
muro e, per andare verso la Portauova , si doveva girare per la
Salita castello. Ora era il momento di don Ciccio.
L’esperto vecchio veniva invocato a
gran voce, come un sacerdote acheo, a celebrare il consueto rito: la
preparazione della “pira.” Nessuno come l'anziano perito agrario
sapeva accatastare con maestria l’enorme “percia”(4) di legna
che occupava il sagrato, circondato dai suoi accoliti pronti a
eseguire i suoi ordini secchi e ad assecondare i suoi gesti
sacerdotali. Egli, dapprima con quattro grossi ceppi sui quali
adagiava delle traverse più lunghe preparava il fornello, il cuore
della focera, poi, piano, piano, sistemava il resto della legna a
cerchi concentrici sempre più ampi alla base e sempre più stretti
al vertice. Alla fine della giornata la focera si ergeva maestosa
nel centro del sagrato, pronta per essere accesa. Non rimaneva altro
che riempire il fornello di frasche secche e “pampuglie” (5) e
aspettare le 8 di sera, quando era prevista l’accensione. Allora
cominciava la trepidante attesa dei monelli che avrebbero voluto dar
fuoco alla catasta già alle cinque del pomeriggio. Però,
nonostante l’impazienza fosse tanta, nessuno osava, compiere
l’atteso gesto per la paura e la soggezione che il vecchio don
Ciccio incuteva e tutti aspettavano il suo arrivo.
Alle
sette, finalmente, il vecchio arrivava insieme a zu ‘Ntone e a un
gruppo di ciucciari, ma non era ancora il momento. I fedeli
cominciavano ad affollare la chiesa, mentre il prete, preso dalle
sue faccende, si faceva, come sempre, attendere. Quando mancava un
quarto alle otto, arrivavano zu Vincenzo con le ciaramelle, zu
Salvatore con il piffero e zu Francesco con le zampogne. Qualche
attimo dopo le dolci note di una pastorale, seguite da quelle di
“Tu scendi dalle stelle”, spandevano l’armonia e la gioia per
via Chiesa e salita Catello, via Buonasera, fino alla Destra. Ora
era giunto il fatidico momento. Don Ciccio inzuppava uno straccio
nel secchio di petrolio che aveva nascosto nell’”orticello” ai
piedi del campanile, lo infilava nel fornello della focera e, con
uno zolfanello, dava fuoco, mentre dalle bocche dei monelli, che
fino a qualche attimo prima disegnavano una curiosa “o”, usciva
un “ohhhh!” di stupore e di gioia. Pochi attimi e migliaia di
gioiose “faille” (6) si libravano in cielo, mentre gli
scoppiettii della legna rallegravano l’ambiente e un tepore
dapprima gradevole, si trasformava in calore infernale e costringeva
gli entusiasti monelli ad allontanarsi di qualche passo. Poco più
in là, seduti sui sedili del sagrato, don Ciccio e gli altri
vecchi, antichi patriarchi, si godevano lo spettacolo come valorosi
guerrieri a riposo, aspirando voluttuose boccate dalle pipe di
creta, lanciando nell’aria nuvole di fumo che si mischiavano a
quello della foera. Intanto era già iniziata la messa di Natale.
Poco prima della mezzanotte nasceva il bambinello e zu Vincenzo,
intonando con la sua ciaramella “Tu scendi dalle stelle”,
partiva dalla porta della chiesa e attraversava, camminando sulle
ginocchia, l’intero tempio per andare a baciare il pargoletto che
il prete, commosso, mostrava ai fedeli. Poi il sacerdote faceva tre
volte il giro della chiesa passando tra i fedeli che baciavano con
devozione il Figlio di Dio.
La focera
oramai ardeva a tutto spiano e le lingue di fuoco, dapprima
altissime, ora cominciavano a scemare. La mezzanotte era passata da
un pezzo e, attorno a quel “frajerinu” (76) cominciavano a
celebrarsi i riti pagani delle patate e delle salsicce arrostite,
arrivavano i soliti fiaschi di vino mentre qualcuno si divertiva a
gettarvi di nascosto qualche castagna che esplodeva fragorosa come
un petardo. E mentre si banchettava, qualche teppistello riusciva
perfino ad infilare di nascosto una brace nella tasca del pastrano
di uno dei tanti vecchi che circondavano la focera. Attimi di
panico, maledizioni all’ignoto mascalzone, imprecazioni, poi tutto
finiva annacquato in un buon bicchiere, fino alle quattro del
mattino quando il sonno e il vino avevano la meglio e il sagrato,
lentamente si spopolava.
All’alba,
un grande mucchio di cenere e alcune braci fumanti, erano tutto
quanto rimaneva del grande falò. Zia Giulia schiudeva l’uscio,
con la paletta riempiva il braciere con quella grazia di Dio e, per
quel giorno almeno, il riscaldamento del suo povero tugurio era
assicurato.
Note
1) Proprietari
di asini, vaticali, uomini che si dedicavano al commercio della legna
2) ciocco,
parte bassa dell’albero
3) radice
dell’albero
4) catasta
di legna
5) foglie
secche usate come esca per il fuoco
6) faville
7) insieme
di braci ancora vive, ardenti
BUON NATALE A LAICI E CREDENTI

Oggi, 21 dicembre, è il Natale
laico, il giorno nel quale l'inclinazione dell'asse terrestre sul
piano dell'eclittica, nell'emisfero boreale tocca il minimo e il
sole, nel suo moto apparente, l'altezza minima sull'orizzonte. In quel
preciso momento i raggi della nostra stessa sono perfettamente
perpendicolari al Tropico del capricorno, un meridiano che taglia più o
meno in due parti uguali l'America del sud 23 gradi e 26 ' a sud
dell'equatore. Per questo motivo, a causa della sfericità della terra,
per l'emisfero sud si tratta del giorno più lungo dell'anno, mentre per
quello nord, dove abitiamo noi, è invece il più corto. Nelle terre
vicino il polo nord la luce è completamente sparita, ma da domani il
corso apparente del sole si invertirà e il dì comincerà ad
allungarsi, dapprima lentamente, poi, dopo qualche giorno, più
velocemente e il sole tornerà a illuminare le cime degli alberi più
altri dei paesi nordici, ovvero la luce rinascerà. Quattro giorni dopo,
il 25 dicembre, questa inversione di tendenza comincerà a essere meglio
percepibile e, finalmente. avremo il Natale della luce che nei millenni
diede origine alle tante metafore di decine di semidei nati tutti
da un dio e da una vergine il 25 dicembre; da Horus a Zoroastro, da
Atiis a Krishna, a Miitra, a Cristo. In ogni caso, che la luce sia un
fenomeno fisico, un fascio di fotoni che illumina la realtà sensibile o
un qualcosa di spirituale, un figlio di Dio che illumina l'anima e
la coscienza, è sempre ben gradita e benvenuta. Buon Natale a laici e
credenti. A proposito di nascita di Cristo e della famosa
cometa, questa sera potremo assistere, nuvole permettendo, a un fenomeno
astronomico che non si ripeteva da dal 1200, cioè da oltre 800 anni,
una straordinaria congiunzione tra Giove e Saturno, i due giganti del
sistema solare che potremmo osservare anche a occhio nudo e che,
per la luminosità del "piccolo treno", ci appariranno come
una cometa, fenomeno che secondo Giovanni Keplero diede origine alla
leggenda della cometa di Betlemm.
A CACCURI (E AI CACCURESI LONTANI)
di Peppino Marino

Dedicata a chi per questo Natale no potrà tornare al suo paese.
Sopra
l'antica roccia
qual faro alle alte genti,
Caccuri, patria mia,
t'ergevi fieramente.
Or
te ne stai, ahimè,
triste e negletta;
i tuoi figli son sparsi per il mondo
ma il cuore d'ogni vero caccurese
palpita forte e pensa al suo paese.
VUCCA
MIA ALLE FRASJOLE!

Ogni è stata una giornata molto
interessante dedicata al taglio e al congelamento della zucca. Ma
se congeli una zucca che fai, la guardi senza prepararti un pranzetto
con questa preziosa cuccurbitacea?
Ed ecco il colpo di genio di mia moglie mentre io preparavo il risotto:
" E se provassimo a farci le frasjole e utilizzare anche la buccia
per farci delle cotolette?" La proposta mi ha convinto e così si
è deciso per un secondo a base di cotolette e di
frasjole di zucca. In altri posti le chiamano polpette, ma per noi sono
frasjole, molto ricercate dai ghiottoni come dimostra la celebre
imprecazione "Vucca mia alle frasjole", ovvero "Boccaccia
mia statti zitta" che si usa per reprimere l'irrefrenabile impulso
di prendere a male parole qualche mascalzone. Il risultato finale
lo potete vedere nella parte destra della foto. Non ho mai capito
perché si continuino a definire zucconi i somari: Ad averne di questi
zucconi a Zifarelli, anche se 4 - 5 l'anno, tranne questo del covid, nel
quale ci siamo dovuti accontentare di una sola, li facciamo
sempre!
Sangue del mio sangue!
di Peppino Marino

Zu Nicola, come tutti i vecchi contadini calabresi, era particolarmente
affezionato al suo somaro. “Quannu m’è morta mogliama nun eppi
dispiaceri, senza suspiri e lacrime la jivi a sutterrari. Mo chi m’è
mortu ‘u ciucciu cianciu cu’ gran duluri, Ciucciu bellu de ‘stu cori, commu te pozzu amà’” canta una
delle più famose canzone della nostra terra che zu Nicola conosceva
benissimo. L’asino per i nostri nonni era un mezzo di produzione e di
sostentamento per tutta la famiglia, l’amico fidato, il compagno di
vita; la malattia o, mai sia detto, la morte del “ciuccio” era
considerata la più grave sciagura che potesse abbattersi sul contadino
e sulla sua casa. Logico, quindi, che tra il padrone e il somaro si
stabilisse un legame affettivo indissolubile, anche perché l’animale,
il più intelligente tra gli animali domestici, più ancora del cane, a
volte dello stesso padrone, nonostante qualche buontempone abbia deciso
che “somaro” debba essere considerato, chissà perché, sinonimo di
ignorante o babbeo, sapeva farsi amare davvero dal contadino calabrese.
Tra l’animale e il proprietario si stabiliva, come dire?, una
“corrispondenza d’amorosi sensi”, una intesa tale che, spesso, era
davvero difficile stabilire chi fra i due era il più cocciuto.
Quella
volta zu Nicola aveva ceduto, con molta riluttanza e trepidazione, alle
reiterate richieste di zu Pasquale, amico carissimo e compare di
sangiovanni, che voleva in
prestito Frisichello per trasportare una una “sarma”di legna da
Cerenzia a Caccuri. “Si vo’ ‘mprestata
a muglierama t’ ‘a ‘mprestu, ma ‘u ciuccio no!”, aveva provato ad obiettare,
ma poi, dopo un lungo tira e molla, col cuore in gola, aveva ceduto alle
implorazioni di zu Pasquale ed aveva acconsentito a prestargli
l’asino, non senza avergli fatto prima duemila e passa
raccomandazioni. Le preoccupazioni di zu Nicola non erano del tutto
infondate dal momento che zu Pasquale era conosciuto in paese per essere
un uomo sciatto, l’unico che non sapesse caricare decentemente un
asino. Mai una volta che fosse riuscito ad equilibrare la “sarma”
per cui gli sventurati asini di cui era stato proprietario avevano
sempre viaggiato con carichi obliqui, di sghimbescio che provocavano
loro fastidiose piaghe alla schiena. L’incapacità del contadino era
nota a tutti, logico che zu Nicola trepidasse per la sorte del povero
Frisichello. Quando il
somarello si allontanò tirato per la cavezza da zu Pasquale, una
lacrima solcò la guancia del povero vecchio, ma nessuno se ne accorse,
tranne un figlio di buona donna, Salvatore, che cominciò a
metterlo in apprensione prospettandogli future sciagure per il povero
animale affidato incautamente ad una bestia come zu Pasquale. Zu Nicola
lo seguì con lo sguardo dal “Pizzo della villa” fino a Canalaci, quando Frisichello, svoltata la curva, scomparve
ai suoi occhi. Poi corse alla Timpa e da lì lo rivide nelle Monache,
dopo aver scavalcato il torrente Matasse e, infine, un puntino appena
percettibile, nei pressi del “ciaramedio” gli fece capire che l’asino era oramai nei pressi di Cerenzia.
Allora zu Nicola si pentì amaramente di aver ceduto alle
insistenze del compare e cominciò a trepidare come non mai per le sorti
dell’asino. Cominciò allora a calcolare il tempo necessario per
raggiungere il bosco, per caricare il somaro e per tornare al ciaramedio,
riproponendosi di aspettare, lì, alla Timpa, di veder
ricomparire “l’amato compagno di vita”. Erano trascorsi una decina
di minuti, forse anche meno, un tempo assolutamente insufficiente a
caricare l’asino quando, alla curva di sant’Antonio, apparve un
puntino nero che, dopo qualche secondo cominciò ad ingrandirsi sempre
più. Dopo circa un minuto era possibile, ma solo ad un occhio di lince,
discernere un asino che, al trotto, percorreva la strada polverosa. “
Frisichello, esclamò zu Nicola, Frisichello sta tornando da solo!”
Finalmente!, ed è anche scarico.” “Frisichello?, disse beffardamente Salvatore, ma no!
Frisichello a quest’ora sarà mezzo carico di legna. Ci penserà zu
Pasquale a scorticarlo a dovere, aggiunse con perfidia per far
imbufalire il vecchio.” “Ma no, è Frisichello, disse ancora zu
Nicola, non lo vedi?”. “Ma come è possibile affermare con tanta
sicurezza che si tratta di Frisichello?, continuò quel buontempone,
ancora è lontanissimo, è difficile riconoscerlo.” “Ma vuoi che non riconosca il mio asino, il sangue del mio
sangue”, sbottò zu Nicola mentre correva già verso la Parte incontro
al suo amato somaro. In un baleno fu a Canalaci a riprendersi il ciuccio
che, evidentemente a conoscenza della incapacità del suo “collega”
zu Pasquale, e, temendo per la propria incolumità, con uno strattone si era liberato del suo probabile aguzzino ed
era prudentemente ritornato al trotto dall’ amato padrone.
' A MERICA
di Peppino Marino
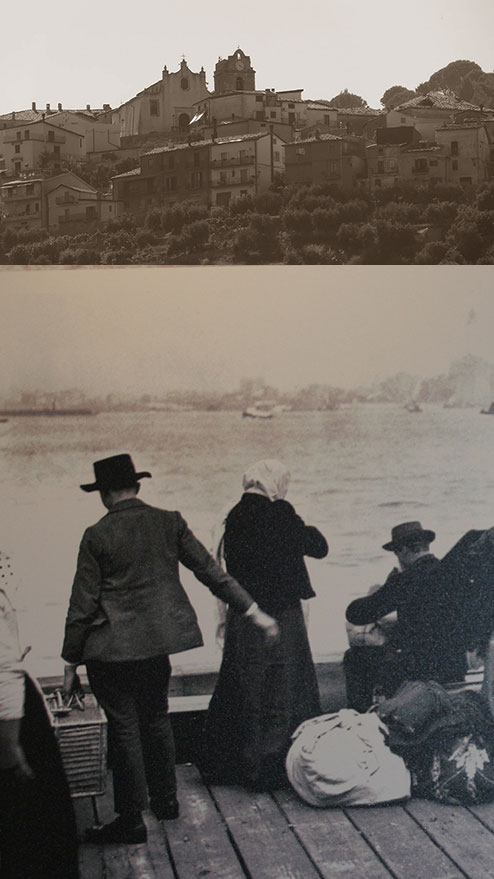
'A Merica,
era il sogno delle giovani
generazioni nel tre decenni a cavallo tra il XIX e il XX secolo quando
milioni di italiani, soprattutto meridionali, lasciarono la loro terra
inseguendo il miraggio che, subito dopo l'unità d'Italia facevano
balenare i nuovi governati per allentare un po' la spaventosa pressione
sociale di popolazioni depredate e gettate (o quantomeno
mantenute) nella miseria più nera, come farà De Gasperi nel 1949, e
per potere, con le generose rimesse degli emigrati accumulate giorno
dopo giorno consumando la vita nei pozzi delle miniere del West Virginia
o nelle piantagioni del Brasile, col sudore e col sangue di tanti uomini
che lasciavano la famiglia, i figli, gli affetti più cari nel paese di
origine, alimentare i consumi interni a tutto vantaggio della nascente
industria del nord.
Un sogno che ho cercato di ricostruire nel mio romanzo
"Viaggio per una vita migliore" e in questa canzone tratta dal
mio musical " 'A fine e ru munnu", un sogno che, molto spesso
si rivelava un tragico fallimento o, comunque, falso, tragico, doloroso.
Buona lettura
‘Nu
jornu ‘e ra fatiga cunsumatu
a
Bemmaria alla casa s’è ricotu.
‘Ntra
lu fullune mortu s’è jettatu
pensannu
a cumu ch’ era disperatu.
“Jettu lui sangu ‘u
jornu ‘e stilla a stilla,
pe’
‘sta mugliere e pe’ ‘sta piccirilla,
ma
la famiglia è sempre disperata,
io
pezzentune e muglierama pettiscigata.
Pane
e cipulla è lu manciare mio,
nu
pomaroru, ohi chi grazia ‘e Dio!
Te
rumpi ‘i costi, ma, chissà pecchiri,
‘nu
rrosciu ‘e sordu mai chi tu lu viri.”
Cussì
pensa Pasquale chilla vota
Ntru
lettu mentre chi se gira e vota.
Paise
brutto, ma va fa ncinefrica,
finiscia
ca mo partu pe’ l’America.
Si,
Cuncettina mia, mo minne vaju
A
Nova Jorka oppure ‘ntra l’Ohaiu.
I
dollari jazzanu e io, ‘ntermine ‘e nente,
diventu
riccu, ‘un signu cchjiu pezzetente!
Due
va’, due va’, già chiancia’ Cuncettina,
si
va all’America pe’ nue è la ruvina.
Se
sciolla la famiglia e, certamente,
finiscìa
ca si sempre nu’ pezzente.
Sta
piccirilla resta senza e tia,
e
senza maritu poi chi biri a mia!
Stamme
a sentire, ca io mai è sbagliatu,
“Chi
nascia’ tunnu ‘un po’ morire quatratu!”
Chi
sta ricennu, un m’agurare ‘u male,
ca
n’arrcchimu, sentalu a Pasquale.
Poi
viri quantu sordi me guaragnu
Ca
io re la fatiga nun me spagnu.
Pasquale
è capitostu, ‘un se rimollari
‘ntra
capu sue ce sunnu sulu i dollari
‘e
Cuncettina ‘un senta lu lamentu
N’capu
a ‘nu mise è supra ‘u bastimentu.
A
Nova Jorka jobba ‘un na trovatu
nè
a Pizzuburgu, a Boston, a Cincinnatu
e
doppo quattro o cinque settimane,
re
lu pitittu vara cu ‘nu cane.
Senza
fatiga, dollari, malatu
Gira
sperdutu, poveru e scornatu.
Doppu
nu mise va n’tra ‘na minera
A
fatigare re matina a sera.
Guaragnari
quattru sordi pe’ campare
Ma
a Cuncettina nun ne po’ mannare,
pe’
chissu ‘un scrivari, ca senta lu scornu
ma
supra ‘a frunte l’è natu già ‘nu cornu.
NEBBIA
di Peppino Marino

Buongiorno,
amici lontani,
stamattina la nebbia avvolge davvero "il morto borgo",
ma stavolta la pioggia è finalmente caduta abbondante, come ci voleva e
i meteorologi ci hanno finalmente azzeccato. Buona domenica a tutti voi.
La
grigia nebbia
Avvolge
il morto borgo
Ed
una pioggerellina,
Fitta
e fina,
Penetra
nelle ossa
Assieme
alla tristezza.
Non
pioggia scrosciante,
Pioggia
abbondante
Che
disseta
E
dà la vita
Che
anch’essa ormai fugge
Questo
paese triste e desolato.
FILASTROCCA AI TEMPI DEL COVID
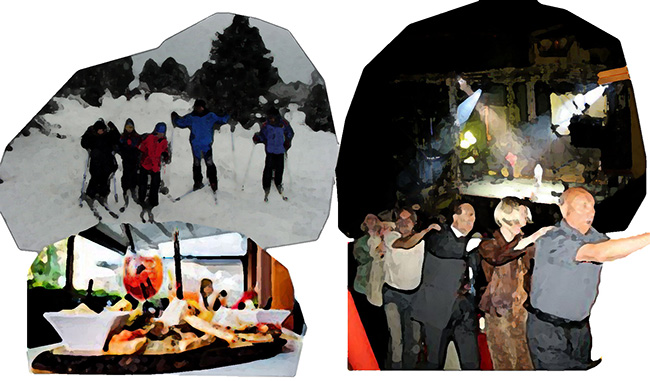 *
*
Tredici trottole
trotterellavano
Trenta
massaie al fiume lavavano.
Luca disegna sul foglio il suo sogno,
Marica studia la storia e s’impegna
Franco, imitando Pasquale, s’ingegna
Vanessa
ascolta una nenia: che lagna!
In questo mondo è tutto un mugugno
Chi c’ha la tigna e chi c’ha la rogna
E c’è chi deluso poi getta la spugna.
Perché la gente è davvero strana,
chi la vuol cruda e chi la vuol cotta
mentre c’è chi non ha una pagnotta
con cui sfamare la sua famiglia,
la moglie, la madre, il figlio e la figlia,
ma si rassegna senza sbraitare;
è disoccupato, non può lavorare;
senza lavoro non c’è da mangiare,
ma tanta gente continua a latrare
perché a Natale non potrà sciare
perché, per salvare qualche vecchietto,
questo governo vuol chiudere tutto.
Chi
se ne frega della pandemia!
Riapriteci
subito pista e sciovia!
Aridadeci
le discoteche,
l’apericena,
i party, le ciucche
il
veglione di capodanno.
E
che si crepi nel resto
dell’anno;
FILASTROCCA
DI DICEMBRE

Filastrocca
delle ombre
Eccoci, alfine, nel freddo dicembre,
il mese nel quale, senza ombra di danno,
cala il sipario per il vecchio anno,
mentre in paese si ammazza il maiale
perché a dicembre si è già a Natale,
il compleanno di Nostro Signore
che viene al mondo e non trova tepore,
perché oltre al gelo di un tempo inclemente,
spesso, c’è quello che
emana la gente
che, in preda al più becero egoismo,
ha messo al bando amore e altruismo
per cui non basta un babbo Natale
a bandire dal modo l’odio e il male.
Però il Natale ci rende più umani,
più solidali, altruisti e più buoni
talché arrivati a
Capodanno,
malediciamo il vecchio anno
e, come è d’uso per il trasformista,
al nuovo anno facciamo la festa,
salvo aspettare ancor San Silvestro,
per preparagli di nuovo il capestro.
