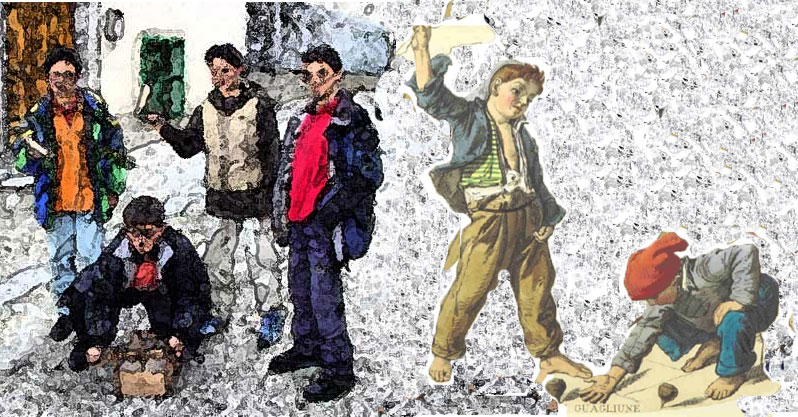|
Giochi della nostra infanzia caccurese |
|
'A sgammia (Gioco del cappello) Questo gioco era molto praticato nei primi decenni del XX° secolo, anzi si può affermare, senza tema di smentita, che fosse il più praticato, fino a quando, a seguito di un paio di incidenti di una certa gravità, fu dismesso completamente. Consisteva nel prendere a calci il cappello, (che a quell'epoca, anche tra i fanciulli, era un indumento diffusissimo) del malcapitato di turno, fino a quando il proprietario non riusciva a strapparlo dai piedi degli altri giocatori. Quando ci riusciva, toccava a chi aveva sferrato l'ultimo calcio, evidentemente non bene assestato, mettere per terra il suo cappello e cercare, a sua volta, di recuperarlo più o meno intatto. Per stabilire a chi toccava "l'onore" di depositare a terra il primo cappello, si faceva la conta. Questo simpatico gioco, quando non ci scappava la frattura della tibia o del perone, procurava, evidentemente, molto lavoro ai cappellai, mestiere all'epoca molto praticato e ora scomparso, forse anche a causa della scomparsa della "sgammia". 'A sguìglia (La lippa)
'A sguglia era
una variante tutta caccurese del famoso gioco della lippa. Ne
esistevano due versioni: "a una sola ruota" e "alle
due ruote." Nella variante a una sola ruota si giocava in due o
tre. Si tracciava in terra un cerchio del diametro di un paio di
metri, si fissava un tetto di punti da totalizzare per vincere la
partita e si faceva la conta. Chi vinceva la conta aveva diritto di
battere per primo, allora si metteva nel cerchio, impugnava un
bastone ('a sguìglia) della lunghezza di una sessantina di
centimetri e con essa colpiva " 'u sguiglìnu" (la lippa),
un bastoncino di una ventina di centimetri appuntito alle due
estremità, spedendolo il più lontano possibile. L'altro
giocatore andava a raccoglierlo e, dal punto in cui era caduto, lo
rimandava verso il battitore cercando di farlo cadere all'interno
del cerchio. Se ci riusciva diventava a sua volta battitore
invertendo i ruoli con l'avversario. Il battitore, quando si vedeva
rimandato indietro " 'u sguiglìnu", cercava di colpirlo
al volo mandandolo il più lontano possibile. A questo punto, aveva
tre possibilità di incrementare ulteriormente il bottino di punti.
Allora colpiva con la "sguiglia" " 'u
sguglinu" su una delle due punte. " 'U sguglinu" si
sollevava di qualche centimetro e il battitore, al volo, lo colpiva
e lo allontanava ulteriormente dal cerchio. Questo, come già detto,
per tre volte, pronunciando, ogni volta queste parole:
"pizzu" per il primo colpo, "pane" per il
secondo e "sazizza" per il terzo. Allora valutava la
distanza tra " 'u sguiglinu" e il cerchio e calcolava
quante volte in questa distanza poteva essere contenuta la lunghezza
della "sguiglia." Poi chiedeva all'avversario"
"Me ne dai tot.?" intendendo, "secondo me ci
sono tot. sguiglie, mi dai tot punteggio?" Se
l'avversario si rendeva conto che la richiesta era congrua,
accettava, altrimenti chiedeva la verifica. Se dalla verifica
risultava che il numero dei punti richiesti superava la distanza, il
battitore perdeva e doveva cedere la battuta. Vinceva, ovviamente,
chi raggiungeva per primo il tetto di punti prefissato. 'U cannatellu (il barattolo)
" 'U
cannatellu" era una intelligente variante della famosa
"ammucciatella" (il nascondino), uno dei giochi più
praticati dall'infanzia di tutti i continenti, apportata dalla
geniale inventiva di un ragazzo caccurese che abitava al rione
Parte, nei primissimi anni '60. Ignoro, purtroppo, il nome di
questo intelligentissimo ragazzo che ora dovrebbe essere un
tranquillo sessantenne e che dovrebbe abitare nel Nord dell'Italia. Se
qualche lettore, o lo stesso interessato potesse fornirmi qualche
notizia in merito inviandomi una e mail, gliene sarei davvero grato. I buttuni (I bottoni)
Anche del gioco
dei bottoni esistevano due varianti: "allu vulu" e
"allu battu", ossia al volo o alla battuta. Quando si
giocava "allu vulu" tra due giocatori, ciascuno di loro
metteva in palio un certo numero di bottoni. Si stabiliva, per
conta, chi dovesse assumere per primo il ruolo di
scommettitore, mentre l'altro si metteva tra le mani chiuse a coppa
i bottoni, li agitava a mo' di bussolotti, e li lanciava per aria,
mentre lo scommettitore doveva pronunciare una parola del tipo
"testa o croce". Quando i bottoni toccavano terra, si
controllava il verso. Quelli del verso indovinati andavano allo
scommettitore, quelli del verso opposto toccavano al lanciatore,
dopo di che i ruoli si invertivano. A volte capitava che uno dei
bottoni cadesse un po' inclinato " 'mpernu" per cui
risultava assai difficile stabilire il verso e allora si producevano
interminabili discussioni che richiedevano anche autorevoli
arbitrati.
' U rrummulu (La trottola)
Prima di parlare
del gioco bisogna premettere che, per il 90%, i
"rrummuli" dei fanciulli caccuresi, erano fabbricati dagli
stessi, spesso mettendo a repentaglio le mani esposte,
pericolosamente, alle asce o alle raspe. Ma si trattava, quasi
sempre, di veri e propri gioielli. I migliori erano quelli di
"ilice" (elce, leccio), un legno molto duro che preservava
" ' u rumulu" dai danni di cui parleremo in seguito. Le
trottole che si compravano nei negozi, colorate e con la parte
inferiore rigata, venivano disprezzate dai ragazzi che le chiamano
spregiativamente "tavulonzi" (tavoloni, pezzi di legno
molliccio). Il gioco consisteva nel lanciare la trottola,
attorno alla quale si attorcigliava un lungo spago, cercando
di colpire con la punta, quella del malcapitato di turno che era
costretto a "parare", cioè a lasciare la propria trottola
per terra alla mercè degli spietati compagni. Ovviamente le punte
delle altre trottole lasciavano il segno, soprattutto se quella
"parata" era un "tavulonzo". Se non la si
colpiva direttamente, il lanciatore aveva la possibilità di
prendere sul palmo della mano la propria trottola mentre ancora
girava, accostarsi a quella "parata" e colpirla con la
propria ancora in movimento. Se il lanciatore non riusciva a colpire
la trottola direttamente o nemmeno con la sua prendendola sul
palmo della mano mentre ancora girava o, addirittura, non riusciva a
fare girare la propria, doveva rassegnarsi a "parare" a
sua volta "il suo rrummulu" e assistere ai generosi
tentativi di disintegrarglielo.
'U latru e la pecurella (Il ladro e la pecorella)
Questo gioco era
la disperazione dei nostri genitori, dal momento che si praticava,
generalmente, di notte, dopo le otto di sera, nelle buie periferie,
se non addirittura nelle campagne attorno al rione
Croci, da gruppi di ragazzi divisi in due squadre: i ladri e i
carabinieri. I ladri "catturavano" una pecorella, di
solito uno dei ragazzi più giovani, e se la portavano via, mentre i
carabinieri si davano alla caccia nel tentativo di catturarli e
liberare l'ostaggio. Ovviamente, all'inizio, i carabinieri dovevano
dare qualche minuto di tempo ai ladri per permettere loro di
involarsi; poi cominciavano le ricerche che, spesso, si protraevano
per delle ore, portando lo scompiglio tra le famiglie che non
vedevano rientrare a casa i figli ad un'ora decente. Non era raro il
caso in cui i ladri e la pecorella, vigliaccamente, vinti dal sonno
o dalla noia, se ne tornavano di soppiatto a casa e se ne andavano a
letto, senza "costituirsi" ai poveri carabinieri che
continuavano a cercarli inutilmente per ore e che, per sovrapprezzo,
al ritorno a casa, si buscavano gli scappellotti dei padri
inferociti.
|